Comunicato stampa n.8
Conclusa la sessione di formazione ecumenica 2019 del SAE
 «Una storia non è compiuta finché non si racconta e non si canta». La frase di Maria Zambrano, filosofa della poesia, è stata citata nella plenaria dedicata alla restituzione degli otto laboratori che hanno rappresentato una porzione significativa della sessione ecumenica del Sae, conclusa sabato 27 luglio. Narrazioni, canti e anche danze hanno accompagnato gli ultimi due giorni della formazione che l’associazione interconfessionale per l’ecumenismo e il dialogo organizza da oltre cinquant’anni. Nell’assemblea che ha raccolto le opinioni e le risonanze sui giorni vissuti insieme è stata avanzata e votata da tutti i partecipanti la proposta di aderire alla lettera scritta a Mattarella e a Conte dalle clarisse e carmelitane scalze a favore dei migranti e rifugiati che cercano protezione in Italia.
«Una storia non è compiuta finché non si racconta e non si canta». La frase di Maria Zambrano, filosofa della poesia, è stata citata nella plenaria dedicata alla restituzione degli otto laboratori che hanno rappresentato una porzione significativa della sessione ecumenica del Sae, conclusa sabato 27 luglio. Narrazioni, canti e anche danze hanno accompagnato gli ultimi due giorni della formazione che l’associazione interconfessionale per l’ecumenismo e il dialogo organizza da oltre cinquant’anni. Nell’assemblea che ha raccolto le opinioni e le risonanze sui giorni vissuti insieme è stata avanzata e votata da tutti i partecipanti la proposta di aderire alla lettera scritta a Mattarella e a Conte dalle clarisse e carmelitane scalze a favore dei migranti e rifugiati che cercano protezione in Italia.
E’ stata una edizione molto partecipata nelle preghiere e nelle liturgie, momenti che hanno aperto e chiuso ogni giornata; nelle relazioni in plenaria che hanno ottenuto un ascolto attento e suscitato domande e riflessioni; nei lavori di gruppo di cui si è relazionato nelle interviste realizzate da Riccardo Maccioni, caporedattore di Avvenire. Vivace il clima, anche per la presenza di bambini e ragazzi, affidati alle cure di un animatore e di un’animatrice, che hanno offerto a tutti un saggio finale che ha preso spunto dalle attività realizzate, e per la presenza di giovani di diverse confessioni che hanno partecipato ai lavori e sono stati coinvolti dal gruppo liturgico.
Un momento alto di memoria è stata la narrazione spettacolo di Marco Campedelli intitolata “La passione secondo Giovanni: raccontare la profezia dell’abate Franzoni” che ha rievocato la figura di un cristiano che ha cercato di vivere e divulgare lo spirito del Concilio Vaticano II.
La sessione del Sae, a cui sabato ha portato un saluto la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ha valorizzato il contesto francescano, sia nella tematica – il rapporto con la povertà e i beni della terra - sia nella scelta dei luoghi che hanno ospitato le liturgie: al santuario di Rivotorto si sono svolti i Vespri ortodossi, nella basilica di Santa Maria degli Angeli una delle preghiere ecumeniche. La Domus Pacis, sede del convegno, ha ospitato nella sua cappella all’aperto l’Eucaristia e la Santa Cena. L’ultima liturgia è stata la preghiera ecumenica di accoglienza dello Shabbat, condotta da Sandro Ventura, con una grande condivisione che ha aperto l’ultimo giorno della sessione. Per il Sae l’ecumenismo tra i cristiani è stato sempre a partire dal dialogo con gli ebrei. Lì è la sua sorgente e la sua forza.
Nelle conclusioni, il presidente del Sae Piero Stefani, ha ripreso il tema della povertà, che è stato affrontato durante la settimana in diverse declinazioni, focalizzandosi sulla cifra che accomuna tutta l’umanità. Siamo tutti mendicanti, come diceva Lutero al limitare della sua vita, e questa povertà radicale che ci accomuna ci chiede di non tirarci indietro verso il prossimo che ci interpella per un aiuto nella difficoltà. Quello che possediamo non è nostro, perché la terra è di Dio, e ciò che ci viene chiesto di offrire non è che una restituzione. Oggi però la maggior parte dell’umanità vive in povertà estrema e solo una parte minima gode delle ricchezze naturali che spesso “rapina” alle regioni del sud del mondo – Africa e Amazzonia in primis – deprivandole dei beni che farebbero la ricchezza di quelle aree. Di fronte anche al problema dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici e dello sfruttamento indiscriminato dei beni primari – acqua, aria, suolo – la soluzione ai problemi pare ardua da trovare. Si può agire a livello personale e comunitario attraverso il cambiamento degli stili di vita e la riduzione dei consumi ma resta l’interrogativo di come intervenire sul macro, ha detto Stefani. In una prospettiva di fede don Bruno Bignami ha interpellato l’assemblea riunita ad Assisi sulla destinazione universale dei beni che il vangelo prima e una ininterrotta tradizione cristiana che arriva a Francesco autore dell’Evangelii gaudium e della Laudato si’, chiede di promuovere e realizzare. C’è una antropologia da ricostruire, un rapporto con la terra, le sue risorse e gli esseri viventi da recuperare, un senso di comunità da ripristinare. Delle comunità - ha detto Brunetto Salvarani concludendo la tavola rotonda con la teologa Elisabetta Ribet e la filosofa Rita Pilotti sul tema di un futuro possibile, «capaci di ascolto e di narrazione, intergenerazionali, interculturali e interreligiose. Comunità che sanno ancora sognare, come auspicava don Tonino Bello. Vi auguro che abbiate molta speranza e che facciate molti sogni».
Comunicato stampa n.7
Sabato 27 luglio - Restituzione dei laboratori
Una delle ultime plenarie in sala alla sessione di formazione ecumenica del Sae ad Assisi è stata la “restituzione” dei laboratori, i cui referenti sono stati intervistati da Riccardo Maccioni, caporedattore di Avvenire.
Del laboratorio coordinato dal critico Andrea Bigalli e dalla regista Gianna Urizio, che ha proposto uno sguardo mondiale sulla dialettica tra povertà e ricchezza nel cinema, i conduttori hanno espresso le modalità e le finalità. I partecipanti sono stati invitati a imparare ad avere uno sguardo altro dal proprio che aiuta a vedere le contraddizioni del reale. Il cinema, ha detto Bigalli, è un modo di approccio a tutti i tipi di immagine. Mentre il mondo in cui viviamo mostra una alterità culturale e di genere, intorno a noi abbiamo un immaginario ossessivo di stereotipi che ci assedia.
Il laboratorio ha cercato di guardare come i poveri guardano se stessi. Secondo Urizio, la povertà può essere narrata e va guardata con occhio altro e capita. Se non abbiamo uno sguardo plurale, anche su Dio, sguardo che alcuni dei film in visione hanno proposto, non riusciamo a cogliere la complessità del mondo. I lavori hanno anche proposto un metodo di discussione, quindi hanno rappresentato anche un modo altro di essere.
La sperimentazione ha caratterizzato anche il laboratorio sulla narrazione e la scrittura con Marco Campedelli e Raffaella Baldacci: si è formata una piccola comunità narrativa che si è raccontata a partire dal proprio vissuto. La ricchezza e la povertà nei loro significati diversi e plurali sono state analizzate partendo dalla dimensione biografica. Rintracciare ricchezza e povertà nella propria biografia, ha detto Campedelli, significa riscoprire la poliedricità e la polivalenza di questi termini e la povertà affettiva, socio-economica e religiosa che molti possono avere vissuto. Un elemento importante è il lavoro sulle parole: abitarle in un processo narrativo dovrebbe farcele percepire come orizzonte, come casa da abitare. Nel laboratorio è emersa anche l’idea di scrivere una lettera alle chiese per invitarle a raccontare delle storie belle, a vivere il racconto come dono, a confrontarsi sulle questioni fondamentali che toccano l’esistenza – i bilanci economici, le scelte ecologiche, gli stili di vita -, a diventare luoghi significativi di contro-narrazioni sul mondo. Infine l’importanza di investire sulla formazione culturale, sull’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani, percepite come priorità. Non ultima la teologia, definito come bene di prima necessità: secondo i partecipanti la formazione in questo campo dovrebbe essere prioritaria per favorire in tutti un’emancipazione teologica.
Il gruppo sul trinomio giustizia, pace e salvaguardia del creato, moderato da Brunetto Salvarani, ha lavorato tra memoria e futuro. E’ stato rilevato che sono cambiati gli equilibri geo-politici, non siamo più nell’Europa del 1989 prima della caduta del muro, quando a Basilea fu celebrata la prima Assemblea ecumenica europea. E’ cambiato il concetto di missione, avanza la realtà dei fondamentalismi, è cambiata la geografia delle religioni: oggi siamo di fronte a un cristianesimo globale. Il gruppo ha immaginato delle buone pratiche concrete da proporre alle chiese tali che si riesca a mantenere la memoria della custodia del trinomio. Due sono i percorsi individuati: il primo è il rilancio della Charta Oecumenica, firmata dalle Chiese europee nel 2001, un’opportunità di crescita non sufficientemente utilizzata, di cui si incoraggia la diffusione a tappeto in Italia. Il secondo percorso è la diffusione della dichiarazione di Abu Dhabi, che ha dato frutti preziosi come l’istituzione di dodici luoghi di culto cristiani negli Emirati arabi uniti. Il Sae, è stato detto, può avere un ruolo nella promozione del testo a livello locale nelle parrocchie e nelle chiese.
Il gruppo “Accoglienza, integrazione, dignità umana”, ha indagato se ci sia e quale sia la cifra costitutiva di queste tre dimensioni e l’ha trovata nella parola “ospitalità”. In un secondo momento i partecipanti hanno ricercato le motivazioni che spingono a pensare e a fare ospitalità per poi narrare delle buone pratiche nell’ospitalità nel mondo pentecostale, ortodosso e nell’islam. Nella discussione è emerso che i codici scritturistici di ogni tradizione religiosa sono codici antirazzisti. L’ospitalità e il dialogo possono portare alla riscoperta di relazioni sociali e civiche e a ripensare alla nostra identità come ospitalità e frutto di relazioni.
Il laboratorio “Crisi ecologica, vecchie e nuove povertà” ha lavorato in quattro tappe: un’analisi del contesto, che si è mossa tra i cambiamenti climatici e la riduzione dei beni comuni; il pensiero teologico cristiano sulla situazione; la riflessione liturgica attorno a una celebrazione del creato; le buone prassi, una delle quali può essere “la mia conversione ecologica per l’anno 2019-2020”: l’assunzione di un impegno nella propria vita personale e comunitaria.
E’ possibile un’altra economia? Di questo tema si è occupato il settimo laboratorio che ha adottato il metodo “vedere giudicare agire”, che ha incluso la riflessione scritturistica sui modelli di città. E’ stato analizzato il nodo economia – finanza; si è parlato dell’economia francescana per il bene comune, dell’economia di comunione, di consumo critico e di una nuova politica per governare il mercato della finanza.
Nel laboratorio “La giustizia e la vita delle donne” è stata esposta una ricerca sul fenomeno del caporalato che intercetta e schiavizza le donne nel silenzio generale. Dall’analisi della realtà si è passati allo studio biblico sulle figure di Agar e Tamar, donne che hanno subito esclusione e violenza. Dalla presentazione è emerso che occorre fare un’altra esegesi di questi passi: la schiava Agar è cacciata dagli uomini ma protetta da Dio e Tamar esercita il suo diritto di dire di no. Nelle Scritture le donne trovano un riscatto. E’ stato poi presentato l’Appello ecumenico di dieci chiese italiane contro le violenze sulle donne e per una presa di responsabilità e un’educazione nelle comunità ecclesiali e nella società, a cui è seguita nel marzo del 2019, su iniziativa di donne cristiane, ebree, musulmane, buddhiste, induiste, la nascita dell’Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne. L’organismo si pone in continuità con l’Appello del 2015 per sensibilizzare le chiese, le religioni e la società su un nuovo modo di rapportarsi tra uomini e donne che escluda la violenza, promuova il dialogo e costruisca il mondo nella giustizia.
Comunicato stampa n.6
Venerdi 26 luglio - Testimonianze ecumeniche
Da tre diverse aree provengono le testimonianze ecumeniche su ricchezza e povertà che si sono alternate nell’ultimo pomeriggio della sessione ecumenica del Sae in chiusura sabato ad Assisi. A Milano in piazza Greco il Refettorio ambrosiano, ideato durante l’Expo dallo chef Massimo Bottura e da Davide Rampello della Triennale, ogni sera serve i pasti a un centinaio di persone in condizioni disagiate. E’ una mensa sui generis, improntata alla bellezza, per la quale sono stati chiamati a raccolta chef stellati che hanno insegnato ai volontari a preparare raffinati menù attraverso il riutilizzo di derrate alimentari invendute donate alla Caritas ambrosiana dai mercati generali e dalle aziende. «Il refettorio è una realtà a molte dimensioni che non fornisce solo cibo ma costruisce percorsi di accompagnamento e di promozione umana - hanno spiegato Marco Colombo e Laura Lavizzari -. A fianco della chiesa di Greco c’è un vecchio teatro degli anni ‘30 ristrutturato da artisti del Politecnico che lo hanno reso un luogo unico di ristoro del corpo e dell’anima, improntato alla solidarietà e all’educazione alla bellezza. Per entrare si passa attraverso la “porta dell’accoglienza” che è una copia della porta di Lampedusa e riconduce a quella realtà. Dopo il periodo dell’Expo la struttura ha acquisito un’organizzazione permanente ed è gestita dalla Caritas e dall’associazione “Farsi prossimo”. Il Refettorio organizza incontri ecumenici e di dialogo interreligioso, serate di testimonianza, scambio di esperienze in un quartiere accogliente e aperto alla multiculturalità in cui c’erano già iniziative solidali e altre ne sono nate su influsso del Refettorio che è cresciuto anche per impulso del parroco don Giuliano Savina. I testimoni parlano di un “patto di alleanza” che si può stipulare con gli ospiti.
A Bologna, al carcere della Dozza, è nata alcuni anni fa un’esperienza di dialogo interculturale e interreligioso che ha prodotto il docufilm Dustur (Costituzione), regista Marco Santarelli, proiettato alla sessione giovedì sera. L’esperienza è stata avviata dal monaco Ignazio De Francesco, della Piccola Famiglia dell’Annunziata, fondata da Giuseppe Dossetti, studioso di letteratura cristiana antica e di fonti islamiche, con alle spalle dodici anni in Medio Oriente dove è stato testimone della seconda Intifada. «Un amico volontario alla Dozza mi disse che c’erano tanti musulmani - ha raccontato rispondendo alle domande di Riccardo Maccioni, caporedattore di Avvenire - ma non volli fermarmi ai soliti servizi che si fanno agli ospiti. Ho cercato di orientare il lavoro verso approcci culturali, per allargare la mente del detenuto che rischia di diventare una cella». Sono iniziate così nella biblioteca del carcere, in collaborazione con altri amici impegnati nel dialogo, le letture di testi islamici, gli scambi sulle primavere arabe e poi l’idea di leggere le costituzioni dei paesi arabi e l’italiana con i detenuti. «Il carcere è un luogo di elaborazione culturale molto importante, è il punto d’un incontro di culture che ci consente di pensare a come progettare il futuro, a come fondare un Islam europeo e italiano». Il passaggio successivo è stato il tema religioni e cittadinanza, favorito da un’esperienza di giovani di diverse fedi che hanno esplorato i luoghi di culto e le comunità della città. «Da questo progetto, che ha generato il docufilm “I nostri”, ci è venuta da idea di portare i giovani in carcere con l’obiettivo di analizzare il tema delle religioni per la cittadinanza. Nella realtà della detenzione la religione è molto importante: emerge nelle potenzialità positive e nella criticità. Il passaggio dall’ateismo alla fede è forte. Abbiamo storie molto commoventi. In carcere si sperimenta la potenza di senso di Gesù Cristo anche come mito».
Un terzo della colletta raccolta durante la sessione sarà devoluta ad Amico volontario che ha subito recentemente il furto di strumenti costosi utilizzati nella cucina della mensa. Dei due terzi rimanenti uno andrà al Refettorio ambrosiano, l’altro al progetto nel carcere di Bologna.
Comunicato stampa n.5
Venerdi 26 luglio - La povertà dei ricchi e la ricchezza dei poveri
Alla preghiera mattutina di venerdì 26 luglio della sessione di formazione ecumenica del Sae in corso ad Assisi sono state ricordate con un minuto di silenzio le oltre 150 vittime del nuovo disastro del Mediterraneo avvenuto nelle acque attorno alla Libia. «Mentre noi stiamo pregando, dialogando, discutendo, ancora sono scomparse delle vite, vite che non potremo mai più incontrare», ha detto Erica Sfredda, membro del gruppo liturgico interconfessionale che prepara e guida i momenti di celebrazione. Silenzio e invocazione perché questi fatti non accadano più, perché le politiche cambino, perché le persone, le comunità religiosa e civile non siano sorde al grido degli oppressi e si facciano promotrici di un’altra via e di nuovi stili di vita.
 Anche la sera precedente, che ha ospitato il culto di Santa Cena, la pastora Ulrike Jourdan, che ha presieduto il culto con il pastore e marito William, nella predicazione ha ricordato le persone che ogni giorno devono guardare la morte in faccia. Commentando il brano della vedova di Sarepta (1Re 17), Jourdan ha detto: «Dio ha visto la donna e suo figlio a Sarepta. Dio vede tutte queste madri e tutti questi padri che affrontano l’incubo del mare o del deserto per trovare speranza. Dio vede anche ciò che noi non vogliamo vedere. Dio vede anche ciò che noi preferiremmo cancellare dalla nostra coscienza». La donna straniera che ha condiviso con il profeta Elia le ultime manciate di farina e le ultime gocce di olio rimaste è segno di una generosità anche in situazione disperata. Generosità che si trasforma in vita per tutti. La pastora ha dato testimonianza di quanto gli immigrati ghanesi nella città di Vicenza condividono il loro poco per i nuovi arrivati. «Non ho mai sentito di qualcuno che fosse finito in strada. Forse si ha poco, ma si condivide quel poco. Tutti noi possiamo aprire le nostre mani, come ha fatto la donna di Sarepta, sapendo che in questo gesto non si dà solamente, ma si riceve».
Anche la sera precedente, che ha ospitato il culto di Santa Cena, la pastora Ulrike Jourdan, che ha presieduto il culto con il pastore e marito William, nella predicazione ha ricordato le persone che ogni giorno devono guardare la morte in faccia. Commentando il brano della vedova di Sarepta (1Re 17), Jourdan ha detto: «Dio ha visto la donna e suo figlio a Sarepta. Dio vede tutte queste madri e tutti questi padri che affrontano l’incubo del mare o del deserto per trovare speranza. Dio vede anche ciò che noi non vogliamo vedere. Dio vede anche ciò che noi preferiremmo cancellare dalla nostra coscienza». La donna straniera che ha condiviso con il profeta Elia le ultime manciate di farina e le ultime gocce di olio rimaste è segno di una generosità anche in situazione disperata. Generosità che si trasforma in vita per tutti. La pastora ha dato testimonianza di quanto gli immigrati ghanesi nella città di Vicenza condividono il loro poco per i nuovi arrivati. «Non ho mai sentito di qualcuno che fosse finito in strada. Forse si ha poco, ma si condivide quel poco. Tutti noi possiamo aprire le nostre mani, come ha fatto la donna di Sarepta, sapendo che in questo gesto non si dà solamente, ma si riceve».
All’insegna della condivisione, ma anche di tanti altri significati, è il brano biblico sulla storia di Rut nel primo libro dei Re che ha siglato la preghiera mattutina di venerdì, commentata dal pastore avventista Davide Romano. Rut, anche dopo essere rimasta vedova, vuole condividere il destino della suocera Noemi, rimasta anche lei vedova e privata di due figli. Di origine moabita, etnia ritenuta maledetta dagli ebrei, sceglie di andare con Noemi nella Giudea, patria della suocera, per non abbandonarla, e così assume quel popolo e il suo Dio. Il libro di Rut – ha detto Davide Romano – è un libro di universalismo di popoli e di fedi; un libro di migrazione, dove chi emigra cerca di sopravvivere; un libro della restituzione, perché ai poveri è dato ciò che è stato loro tolto; della Provvidenza, perché Dio non dimentica il povero; di appartenenza non nel senso etnico ma nel senso di una reinvenzione dell’appartenenza: Rut non appartiene al popolo ebraico ma sceglie di appartenervi per “simpatia” con la suocera. E sarà annoverata tra le antenate di Gesù perché sposando Booz e generando Obed entrerà nella genealogia messianica. «In sede ecumenica – ha concluso il pastore – è bene parlare di appartenenza come scelta che non significa ridurre l’appartenenza di partenza ma collocarla in un contesto più ampio di fraternità più grande».
Nel pomeriggio la tavola rotonda condotta da Riccardo Maccioni, caporedattore di Avvenire, con testimonianze ecumeniche sulla “povertà dei ricchi e la ricchezza dei poveri”. Al termine la preghiera ecumenica di accoglienza dello Shabbat.
Comunicato stampa n.4
Giovedi 25 luglio - Il Dio dei poveri
Alla sessione di formazione ecumenica del Sae in corso ad Assisi la giornata di giovedì è dedicata al tema “Il Dio dei poveri”. Poveri sono i migranti, i rifugiati, i senza tetto per i quali alla vigilia si è pregato in una celebrazione ecumenica nella basilica di Santa Maria degli Angeli, di fronte alla Porziuncola, uno dei luoghi cari a Francesco che qui comprese la sua vocazione e accolse i primi frati. Un ricordo alle madri che hanno perso i loro figli nel Mediterraneo e nel deserto, ai prigionieri nei campi di detenzione, a chi è ancora in viaggio per fuggire alla povertà estrema. Una brocca d’acqua, una micca di pane, una coperta termica sono stati i simboli per ricordare quanti bussano oggi alle nostre porte in cerca di quella sicurezza e di quei beni di prima necessità posseduti da chi è chiamato a condividerli.
Il tema del Dio dei poveri è stato introdotto nella meditazione biblica mattutina offerta dal presbitero bolognese Matteo Prodi che ha commentato il brano lucano della chiamata del ricco Zaccheo, in realtà un povero che cerca di vedere Gesù mentre sta entrando in Gerico. «La chiamata di Gesù – “oggi devo venire a casa tua” – è la miccia che accende in Zaccheo una potenza impressionante, segno che qualcosa era pronto in lui. Zaccheo traccia una nitida immagine della chiesa che verrà nella quale “i pubblicani e le prostitute vi precederanno”, cioè nella quale vi apriranno un cammino». La conversione di Zaccheo, ha proseguito Prodi, «è molto laica: mette le mani dove il suo cuore è più attaccato, la ricchezza materiale. Riesce a farlo perché qualcuno si è preso cura di lui, ha messo gli occhi nei suoi occhi». E risuona ancora la visione di papa Francesco, tracciata nella giornata di ieri: le ricchezze sono relazionali e servono per costruire la fratellanza universale. Questo ci dice la decisione di Zaccheo di come disporre dei propri beni. E oggi? Come nei credenti e nelle istituzioni ecclesiali e religiose si valuta e si vive questa realtà? Si è dialogato sul tema nella tavola rotonda interreligiosa il cui titolo ha preso spunto da una frase di Lutero: «”Siamo mendicanti, questo è vero”: il Dio dei poveri». Un tavolo a quattro voci: ebraica, Anna Foa, con un intervento a distanza; cattolica, Stefania Monti; valdese, Paolo Ricca; musulmana, Yassine Lafram.
Nell’ebraismo – scrive Foa - la povertà è relazionata alla zedaquah, l’atto di riparare a essa ad opera dello zaddiq, l’uomo che soddisfa il precetto del soccorrere il povero. Non si tratta di una elargizione volontaria ma dell’osservanza di un precetto. La pratica della carità secondo giustizia aiuta a perdonare i peccati. Secondo l’esegeta medievale Maimonide - noto anche attraverso l’acronimo Rambam – la zedaquah è il precetto che occorre osservare maggiormente. Nella concezione mosaica la ricchezza è un prestito proveniente da Dio e i poveri hanno un certo diritto ai beni dei ricchi, mentre i ricchi sono esortati a condividere la generosità di Dio con i poveri. L’intervento della storica, letto da Piero Stefani, ha riguardato anche la città di Sodoma, una società ricca il cui peccato è il rifiuto dell’ospitalità agli stranieri e della zedaqah ai poveri. In un trattato del Talmud babilonese si parla di due giovani donne punite per aver disobbedito a una legge iniqua di Sodoma che impediva il sostegno ai poveri.
La povertà in Francesco - ha esordito Stefania Monti – «è orientata alla fraternità e alla pace». La clarissa cappuccina ha osservato che «l’essere poveri è un dato della condizione umana». Sia che si nasca in una clinica di lusso o in altro luogo, la fragilità di fondo rimane. Dio ama i poveri e sta dalla loro parte, ma non accetta la povertà che nasce dalla violenza e dalla sopraffazione. Le invettive del profeta Amos e di Giacomo sono abbastanza eloquenti. Nei salmi si parla frequentemente di poveri e povertà. In certi casi chi genera povertà viene considerato omicida. In una situazione che la biblista vede drammatica e con poche soluzioni in vista «possiamo ascoltare i poveri, riconoscersi tali quanto alla ricerca di senso e cercare di cambiare i nostri stili di vita». Francesco ha fatto della povertà la cifra della sua vita, tra i simboli ha preferito la nudità; ha scelto i minores, i più piccoli, una scelta radicale che i suoi frati non hanno accettato.
Il teologo valdese Paolo Ricca, decano dell’ecumenismo in Italia, commentando Martin Lutero si è soffermato sulla povertà in senso esistenziale, trovando tre significati all’affermazione del riformatore: «Siamo mendicanti di senso perché abbiamo difficoltà a capire. Tutto è avvolto nel mistero. Più vado avanti e meno conosco e più il mistero si infittisce. Alla fine della vita solo Dio saprà fare luce sul mistero». Un secondo significato della frase di Lutero secondo Ricca è che il cristiano è povero di potere. Dio è il Dio dei poveri di potere, ma non nel senso mondano della parola potere. Qui c’è l’ambivalenza del discorso biblico sul futuro. Da un lato Gesù stesso dice: “A me è stato dato ogni potere”. E’ vero anche che sta scritto “Voi riceverete potere quando lo Spirito santo verrà su di voi”. E anche prima egli chiamò a sé i suoi discepoli e diede loro potere di cacciare gli spiriti maligni. L’altra promessa impressionante di Gesù riferita da Giovanni è sul perdono dei peccati. D’altra parte Gesù dice: “Senza di me non potete fare nulla”. Siamo totalmente impotenti. Come usciamo da questa contraddizione?». Ricca osserva: «Non abbiamo nessun potere ma abbiamo lo Spirito Santo e la Parola, questa è la dialettica. Non possiamo nulla e possiamo tutto. Siamo mendicanti del potere di Dio in noi, siamo a mani vuote». Infine «siamo mendicanti della grazia, perché non abbiamo nessun merito. La fede ci è venuta misteriosamente, “contro” di noi. Siamo stati fatti prigionieri dalla Parola di Dio, ed eccoci qua. E le nostre buone opere – come la zedaqah di cui abbiamo parlato– sono state preparate da Dio perché le praticassimo. I gesti di amore sono un’iniziativa di Dio che ci introduce nel regno della gratuità dove non c’è più vanto, boria, orgoglio. Perché “chi si vanti si vanti nel Signore”».
Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, per la prima volta relatore alla sessione del Sae, ha premesso il tema inquadrando la religione islamica nei sui capisaldi e mostrando le affinità con la religione ebraica e cristiana con le quali, ha detto, «ci sentiamo legati». «Noi crediamo nei profeti biblici del vecchio e del nuovo Testamento come testi rivelati da Dio. Chi non ci crede non è considerato musulmano a pieno titolo». Felice di partecipare alla tavola rotonda, Lafram ha definito il dialogo interreligioso «non una moda di stagione ma la quotidianità. Teme il dialogo chi non ha un’identità consistente, chi è vulnerabile. Il dialogo aiuta a conoscere l’altro e anche a conoscere noi stessi». Entrando nel tema dell’incontro, ha spiegato che la carità ha un posto importante nel Libro del Corano e nei detti del Profeta (adith) dove è scritto che «l’ombra del credente nel giorno del giudizio sarà la sua carità». Posta l’importanza della preghiera nella vita del musulmano, «anche la carità è intesa da Dio come atto di culto: nessuno sarà credente se non ama suo fratello come ama se stesso. Facciamo parte di un corpo, e se un organo è malato ne risentono anche gli altri. L’accoglienza ha un significato molto importante: chi rifiuta di aiutare un orfano e un povero rinnega Dio. La carità è una virtù da praticare sia nelle avversità che nella prosperità». Lafram ha descritto diversi tipi di elemosina, materiale e spirituale, tra cui la zakat, che è uno dei cinque pilastri dell’Islam, ed è destinata a otto categorie di persone e situazioni. E che sta a ricordare che ciò che si possiede non è nostro, ma è di Dio.
Dopo i laboratori del pomeriggio, si tiene il culto di Santa Cena presieduto dalla coppia pastorale Ulrike e William Jourdan della Chiesa valdese di Genova, con la predicazione sulla pericope della vedova di Sarepta (1Re 17,7-16). In serata la proiezione del film Dustur, frutto di un progetto sulla Costituzione realizzato con gli ospiti del carcere della Dozza di Bologna. Lo introduce Ignazio De Francesco, monaco della Piccola Famiglia dell’Annunziata di Bologna, che vi ha lavorato insieme a Yassine Lafram.
Comunicato stampa n.3
Mercoledì 24 luglio - Ospiti sulla terra dei viventi
Alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli continuano i lavori della sessione di formazione ecumenica del Sae tra relazioni in plenaria, laboratori e liturgie. La giornata di martedì dedicata a “un creato bello e fragile” è stata ricapitolata nell’Eucarestia all’aperto presieduta da don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei. «Sono commosso ed emozionato nello stare in mezzo a voi; mai avrei pensato di presiedere l’Eucarestia a una sessione del Sae» ha detto nell’omelia. Commentando dal Vangelo di Luca il brano della visita di Maria ad Elisabetta, avvenuta tra due annunci e una nascita, don Savina ha detto: «L’esperienza del Sae sta nella Chiesa come l’esperienza gravida di un qualcosa che non dipende da te e che sconvolge la tua vita. Questo è un luogo gravido dove lo Spirito è in azione e dove prende un corpo che sta tra gli annunci e la nascita». In questo terreno di passaggio che apre a un tempo nuovo «c’è tutta la storia dell’ecumenismo, del dialogo interreligioso, qui ci stanno dentro tutti i documenti scritti e firmati e quelli ancora sospesi. questo è un passaggio straordinario, ma chi lo sopporta? Perché questa cosa va sopportata e supportata». Ecco allora l’incoraggiamento di chi è delegato a sostenere la realtà dell’ecumenismo nelle diocesi italiane: «Il Sae ha veramente un compito straordinario dello Spirito e questo seme non può essere disperso, ma chiede a tutti una coerenza e responsabilità straordinaria. I tempi sono quelli di Dio, e l’unità innanzitutto è il suo desiderio prima di essere il nostro».
Il percorso attraverso il rapporto tra Chiese e povertà è proseguito mercoledì con la giornata dedicata al sotto-tema “ospiti sulla terra dei viventi”, aperta dall’intervento biblico di Amedeo Spagnoletto, rabbino capo della Comunità ebraica di Firenze, alla sua prima volta a una sessione del Segretariato attività ecumeniche. La sua comunicazione, che ha rappresentato un brillante esempio di ermeneutica ebraica, ha preso le mosse dal versetto di Levitico 25,23: “La terra è mia – dice il Signore – e voi siete presso di me come forestieri (gherim) e residenti (toshavim)”. Nella visione ebraica prima del rapporto con Dio è fondamentale avere un buon rapporto tra gli esseri umani e nel creato. Questo si inquadra nella condizione di stranierità di ogni essere vivente che è ospite del mondo creato da Dio e quindi non può vantare privilegi di sorta a scapito del prossimo che gli sta accanto. La proprietà della terra da parte di Dio è la garanzia che ci sia spazio per tutti. L’anno sabbatico, la cui istituzione è ricordata in Levitico 13, è l’emblema di questo rapporto tra l’essere umano e il creato, è il ritorno al proprietario originario. «Il Giubileo è un precetto non ostico perché il popolo sa in partenza che la terra è di Dio e quindi va redistribuita nel 50° anno. Occorre che facciamo un lavoro su noi stessi per capire che siamo tasselli di un mosaico più grande di noi» ha ricordato Spagnoletto.
All’esigenza di un diverso rapporto degli esseri umani con i beni della terra ha richiamato anche don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio nazionale dei problemi sociali e del lavoro della Cei, nella sua relazione sulla “Povertà come non solo mancanza di denaro, ma di energia, acqua e aria…”. Oggi siamo di fronte a “fabbriche della povertà”. Invece di diminuire, come auspicato dalle agenzie internazionali dell’Onu, dal 2015 la fame e la povertà nel mondo sono cresciute. Non si tratta della mancanza di cibo: la causa è l’esclusione sociale, di cui le donne sono le maggiori vittime. Le speculazioni finanziarie, che toccano anche i beni di prima necessità, sono una parte del problema. Anche nel campo del lavoro siamo di fronte allo sfruttamento, alla mancanza di sicurezza, alla vulnerabilità. Mentre l’economia rende accessibili smartphone e slot non garantisce a tutti l’accesso al cibo, all’acqua, alla sanità, alla scolarizzazione. «Di fronte al fallimento di un modello economico consumistico occorre acquisire una nuova mentalità, occorre parlare in termini di comunità» ha detto don Bignami. Ascoltare, guardare, sono gli atteggiamenti che possono favorire l’inclusione in un mondo che esclude. E’ un problema anche delle comunità cristiane – ha continuato il relatore - che hanno bisogno di riconciliarsi su un principio fondativo dell’insegnamento sociale della Chiesa che è la destinazione universale dei beni. Sulla quale c’è una lunga tradizione che parte dal Vangelo, dalle lettere apostoliche, arriva alla tradizione patristica (S. Ambrogio, S. Tommaso), ha un riferimento in don Primo Mazzolari (La rivoluzione cristiana), è presente nel Concilio Vaticano II (Gaudium et spes 69) ed è rilanciata da Francesco nell’enciclica Laudato si’: «Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” del comportamento sociale, e “il primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale (LS 93)». Il direttore dell’ufficio nazionale dei problemi sociali e del lavoro della Cei ha citato passi dell’Evangelii gaudium che già danno conto di questa visione della questione povertà. Il problema non è la mancanza di cibo, ma lo spreco e la cattiva distribuzione di cibo e reddito, come hanno detto i vescovi brasiliani citati nell’Esortazione (EG 191). L’intento del papa è una liberazione dall’ideologia del privato «per uno stile di vita e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità al loro passaggio su questa terra (EG 208)». Le persone hanno bisogno di sapere che è meglio vivere nella logica della condivisione che nel consumo egoistico dei beni, ha commentato Bignami. Per questo occorre recuperare il significato dei beni comuni – la terra, l’acqua, l’aria, l’energia – che non sono solo una realtà fisica quantificabile ma costituiscono un fattore di relazionalità. Ogni essere vivente ha una relazione costitutiva con i beni di carattere gratuito. «Nel latte materno - ha esemplificato - abbiamo ricevuto cibo, bevanda, energia, ma soprattutto relazione gratuita. Il seno non è solo nutrimento. E’ affetto, attenzione, prossimità, fiducia, amore. La fiducia del vivere dipende dall’aver ricevuto dei beni che ci hanno mantenuto in vita. Se per mangiare dobbiamo sgomitare o rubare, qualcosa nel sistema non funziona». Oggi i beni comuni sono traditi: land grabbing in vaste aree del pianeta, esclusione all’accesso all’acqua potabile per centinaia di milioni di persone, inquinamento dell’aria, apartheid climatico.
Secondo il relatore alla base di tutto c’è “un’ossessione dell’io” e “un’ossessione del noi” – un “comunitarismo endogamico” - che riguarda anche il mondo cattolico. La Laudato si’ mette in questione questo “antropocentrismo dispotico”. La società dei consumi fabbrica falsi bisogni le cui conseguenze sono una globalizzazione distruttiva, la perdita del senso del limite, un’economia dello spreco, un meccanismo mimetico che fa desiderare ciò che gli altri desiderano, e la fine della disponibilità delle risorse. Di fronte a questo quadro, dentro questo quadro, occorre ripensare il modello di comunità e i rapporti fondativi del nostro esistere, ha concluso Bignami.
Dopo i lavori nei laboratori e un pomeriggio di sosta dedicato alle visite in Assisi e alle relazioni personali la giornata si conclude con una preghiera ecumenica ospitata nel Santuario di Santa Maria degli Angeli.
Comunicato stampa n.2
Martedì 23 luglio - Un creato bello e fragile
Alla sessione di formazione ecumenica del Sae in corso ad Assisi, la giornata di martedì è stata introdotta liturgicamente lunedì sera al santuario di Rivotorto. Padre Ionut Radu, parroco per nove anni della Comunità ortodossa romena di Perugia e di Assisi, trasferito quest’anno a Milano, ha presieduto i Vespri ortodossi. L’intensa preghiera, terminata con la distribuzione del pane benedetto, una tradizione ortodossa mantenuta nei secoli come segno di benedizione ai fedeli, ha incluso un’omelia dell’arciprete, dedicata a San Francesco. Un santo molto amato dai romeni che hanno tradotto in lingua più di quaranta volte il suo Cantico di Frate Sole e amano la sua spiritualità, sentita «come un riflesso della spiritualità ortodossa nel mondo occidentale» ha spiegato padre Radu. Francesco è un uomo che fa confessione di lode e di umiltà e da voce a tutto il creato, sa vedere con gli occhi del cuore, si sente parte del tutto. Non poteva esserci modo migliore per annunciare la giornata sul tema “Un creato bello e fragile”, con la mattina dedicata alla relazione di Simone Morandini sul “Tempo del mutamento climatico: tra fragilità e responsabilità” e quella dell’arciprete ortodosso del Patriarcato ecumenico Sergio Mainoldi sul tema “Al di là dell’utile: bellezza e contemplazione del creato”.
Simone Morandini, vicepreside dell’Istituto di studi ecumenici San Bernardino di Venezia, ha illustrato le fragilità e le responsabilità del tempo che gli esperti definiscono “antropocene”: un tempo nel quale l’agire umano si colloca tra le principali forze che determinano l’evoluzione biologica, fisica e chimica della terra. Non ci sono più dubbi sulla realtà del cambiamento climatico in atto e sul fatto che se entro quindici anni non si inverte la rotta si rischia il collasso irreversibile di ecosistemi. Già abbiamo visto sei isole di plastica in mare, abbiamo assistito alla devastazione di foreste, alle grandi migrazioni di profughi ambientali tanto che si parla di “apartheid climatico”.
 Come abitare questo tempo di grandi contraddizioni e sofferenze?, si è chiesto Morandini. Ha risposto: Ascoltando la voce delle vittime, come suggerisce il Consiglio ecumenico delle Chiese; ascoltando il grido dei poveri e della terra, come scrive Francesco nella Laudato si’; ascoltando le giovani generazioni che ci parlano come Greta Thunberg». Ascoltare richiede di assumere uno sguardo diverso, di ripensare la responsabilità; di sapere che la terra è del Signore e noi siamo stranieri e ospiti. Significa cambiare immaginario, scelte personali, comunitarie e scelte politico-economiche, Diventare amministratori responsabili. Significa ritessere le reti della convivenza. Davanti a noi l’Agenda 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dall’Onu e a novembre, a Firenze, il III Forum di etica civile “Verso un patto tra generazioni: un presente giusto per tutti”, per una polis in armonia con la physis.
Come abitare questo tempo di grandi contraddizioni e sofferenze?, si è chiesto Morandini. Ha risposto: Ascoltando la voce delle vittime, come suggerisce il Consiglio ecumenico delle Chiese; ascoltando il grido dei poveri e della terra, come scrive Francesco nella Laudato si’; ascoltando le giovani generazioni che ci parlano come Greta Thunberg». Ascoltare richiede di assumere uno sguardo diverso, di ripensare la responsabilità; di sapere che la terra è del Signore e noi siamo stranieri e ospiti. Significa cambiare immaginario, scelte personali, comunitarie e scelte politico-economiche, Diventare amministratori responsabili. Significa ritessere le reti della convivenza. Davanti a noi l’Agenda 2030 con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dall’Onu e a novembre, a Firenze, il III Forum di etica civile “Verso un patto tra generazioni: un presente giusto per tutti”, per una polis in armonia con la physis.
L’arciprete Sergio Mainoldi, partendo dall’affermazione del patriarca ecumenico Bartolomeo che «la crisi ecologica è frutto della crisi spirituale» ha messo in luce in che misura la sensibilità teologica e liturgica per la bellezza può contribuire a capire le ragioni spirituali della crisi attuale. La bellezza - ha detto - non può essere tale se non partecipa all’energia divina. La bellezza è relazionale; ha una funzione escatologica perché collega le cose create a Dio e a lui le riconduce. Il compito di custodire e di coltivare affidato ad Adam unisce la dimensione contemplativa e la dimensione della tecnica come prolungamento della creazione. Un’economia senza bellezza si spersonalizza e diventa accumulo di profitto. La concezione dell’utile si basa sulla spersonalizzazione e sullo spaesamento. La crisi spirituale porta a concepire inutile ciò che non è finalizzato all’utile in senso stretto. L’utile spirituale non viene considerato. La bellezza è un utile comune, condiviso, a lungo termine. L’equilibrio, secondo Mainoldi, non può che passare dalla riconsiderazione del ruolo della bellezza.
Comunicato stampa n.1
Con la preghiera mattutina che ha ospitato un caloroso abbraccio tra tutti i partecipanti, circa duecento persone provenienti dall’ Italia del nord, del centro e del sud, è stata inaugurata lunedì 22 luglio alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli la 56 ͣ sessione di formazione ecumenica del Segretariato attività ecumeniche (Sae). Prima dell’introduzione, il presidente, Piero Stefani ha letto il messaggio di monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino. «La vostra lunga storia di dialogo tra le Chiese cristiane – ha scritto il presidente della Commissione episcopale ecumenismo e dialogo della Cei – ha contribuito a far crescere nella Chiesa italiana la necessità di conoscere e comprendere l’altro». Spreafico ha sottolineato il tema su ci è focalizzata la settimana, quello della povertà: «Davvero le Chiese cristiane sono chiamate a uscire ponendosi sempre più di fronte al dramma crescente della povertà, o come direbbe più spesso la Bibbia, dei “poveri”. Uomini e donne come noi che hanno diritto ad essere ascoltati ed amati. L’abisso che separa poveri e ricchi è sempre più profondo. Chi lo colmerà? Questo impegno comune dei cristiani attenuerà le nostre divisioni». A questo proposito il vescovo ha ricordato l’esperienza dei “corridoi umanitari”, «nato e cresciuto in una fraterna collaborazione ecumenica». Il saluto è terminato con un ringraziamento «per l’impegno e la passione con cui ogni anno arricchite il cammino ecumenico nel nostro paese».
 L’articolata introduzione ai lavori di Piero Stefani ha toccato i diversi significati del termine povertà, partendo dalla ricerca di un concetto elementare di ecumenismo, mutuando una definizione sull’etica di Luisito Bianchi. «Che cos’è l’ecumenismo?» ha detto il presidente del Sae. «La chiesa come vorrebbe essere». In questa definizione c’è sia il presente della chiesa, sia il desiderio di essere quello che ancora la chiesa non è. Definizione che indica una realtà presente e mancante, una forma di povertà. Consapevoli che la ricerca dell’unità della Chiesa non può essere separata dalla ricerca dell’unità dell’umanità - qui Stefani ha citato il pastore Paolo Ricca dagli atti della sessione 2018 - il Sae ha deciso di dedicare due sessioni al rapporto delle chiese con ricchezza e povertà. Una decisione “necessaria” e “temeraria”: perché la divisione maggiore tra gli esseri umani è quella tra ricchi e poveri, e perché si tratta di un tema divisivo tra le chiese in ordine alle scelte compiute per farvi fronte. Spesso azioni antitetiche rispetto allo stesso Vangelo ascoltato. E spesso le chiese hanno parlato dei poveri ma non hanno ascoltato la loro voce, non hanno aperto spazi inclusivi. E, nella società grande, citando l’economista Luigino Bruni Stefani ha detto: «esperti non-poveri di povertà parlano, anche in buona fede, di una realtà che non hanno visto né tanto meno toccato e abbracciato come fece, invece, san Francesco di Assisi». Non solo di aiuto necessitano i poveri, scrive il fautore dell’”Economia di comunione” ma «di essere presi sul serio come soggetti e come “persone pensanti”». Il presidente del Sae ha ricordato che proprio ad Assisi l’anno prossimo si terrà il grande convegno voluto da papa Francesco su suggerimento di Luigino Bruni “Economy of Francesco”. Ha ricordato il futuro evento anche il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, nel suo saluto al presidente del Sae, ricordando il bisogno di riflessione su una situazione mondiale che non corrisponde al volere di Dio e augurando alle riflessioni dell’assemblea riunita alla Domus Pacis «una speciale effusione dello Spirito Santo». Concludendo, Piero Stefani ha ricordato le due mani dell’icona che caratterizza la sessione Sae 2019: la mano del ricco che offre un sacchetto pieno e la mano della povera vedova che offre i suoi due spiccioli. Sottolineando da una parte «la responsabilità di chi oggi riceve l’offerta dei poveri» e dall’altra che «nelle contraddizioni della società Dio è in grado di vedere e di giudicare le profonde e invisibili intenzioni del cuore». «La preghiera del povero fa un fardello di tutte le altre preghiere del mondo» è scritto nel citato Zohar, “libro dello splendore”. Qui, ha commentato Stefani, si mostra in maniera indimenticabile cosa significhi agli orecchi di Dio la “scelta preferenziale a favore del povero”.
L’articolata introduzione ai lavori di Piero Stefani ha toccato i diversi significati del termine povertà, partendo dalla ricerca di un concetto elementare di ecumenismo, mutuando una definizione sull’etica di Luisito Bianchi. «Che cos’è l’ecumenismo?» ha detto il presidente del Sae. «La chiesa come vorrebbe essere». In questa definizione c’è sia il presente della chiesa, sia il desiderio di essere quello che ancora la chiesa non è. Definizione che indica una realtà presente e mancante, una forma di povertà. Consapevoli che la ricerca dell’unità della Chiesa non può essere separata dalla ricerca dell’unità dell’umanità - qui Stefani ha citato il pastore Paolo Ricca dagli atti della sessione 2018 - il Sae ha deciso di dedicare due sessioni al rapporto delle chiese con ricchezza e povertà. Una decisione “necessaria” e “temeraria”: perché la divisione maggiore tra gli esseri umani è quella tra ricchi e poveri, e perché si tratta di un tema divisivo tra le chiese in ordine alle scelte compiute per farvi fronte. Spesso azioni antitetiche rispetto allo stesso Vangelo ascoltato. E spesso le chiese hanno parlato dei poveri ma non hanno ascoltato la loro voce, non hanno aperto spazi inclusivi. E, nella società grande, citando l’economista Luigino Bruni Stefani ha detto: «esperti non-poveri di povertà parlano, anche in buona fede, di una realtà che non hanno visto né tanto meno toccato e abbracciato come fece, invece, san Francesco di Assisi». Non solo di aiuto necessitano i poveri, scrive il fautore dell’”Economia di comunione” ma «di essere presi sul serio come soggetti e come “persone pensanti”». Il presidente del Sae ha ricordato che proprio ad Assisi l’anno prossimo si terrà il grande convegno voluto da papa Francesco su suggerimento di Luigino Bruni “Economy of Francesco”. Ha ricordato il futuro evento anche il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, nel suo saluto al presidente del Sae, ricordando il bisogno di riflessione su una situazione mondiale che non corrisponde al volere di Dio e augurando alle riflessioni dell’assemblea riunita alla Domus Pacis «una speciale effusione dello Spirito Santo». Concludendo, Piero Stefani ha ricordato le due mani dell’icona che caratterizza la sessione Sae 2019: la mano del ricco che offre un sacchetto pieno e la mano della povera vedova che offre i suoi due spiccioli. Sottolineando da una parte «la responsabilità di chi oggi riceve l’offerta dei poveri» e dall’altra che «nelle contraddizioni della società Dio è in grado di vedere e di giudicare le profonde e invisibili intenzioni del cuore». «La preghiera del povero fa un fardello di tutte le altre preghiere del mondo» è scritto nel citato Zohar, “libro dello splendore”. Qui, ha commentato Stefani, si mostra in maniera indimenticabile cosa significhi agli orecchi di Dio la “scelta preferenziale a favore del povero”.
Le prime due relazioni della giornata hanno riguardato il futuro visto dal sud e dal nord del mondo. Hans Gutierrez Salazar, della Facoltà avventista di teologia, ha parlato della divisione insormontabile tra nord e sud del mondo che non è solo un divario economico sempre più radicalizzato, ma in cui si intravvedono diversi modi di intendere il mondo. Un modo “europeo”, nato nella modernità, che si stacca, che esclude le altre civiltà considerate primitive e la natura, che ha il mito del progresso a ogni costo. E una società dell’equilibrio, che valorizza le persone, che preferisce la cura dei rapporti all’accelerazione e all’ipertrofia dell’io.
Vincent I. Ifeme, delegato dell’ecumenismo della diocesi di San Benedetto del Tronto- Ripatransone - Montalto, ha portato una testimonianza di un uomo tra due mondi, l’Italia e la Nigeria, a partire dalle discriminazioni economiche, dalla mancanza di giustizia, da un pervasivo neo colonialismo mascherato, dalla corruzione dei governanti. L’Africa come paradosso di un continente ricco che affonda nella povertà e in cui spesso conflitti tribali e politici vengono spacciati come conflitti religiosi. Anche le Chiese, ha osservato Ifeme, hanno spesso la responsabilità di non essere state dalla parte dei poveri. Ma «l’Africa è anche bella, forte, resiliente, spirituale. La risposta ai suoi numerosi problemi deve venire dalle sue qualità più positive, più belle».
Nel pomeriggio il tema della povertà come metafora delle divisioni delle chiese con il monaco Guido Dotti e la pastora luterana Eva Guldanova. Al termine i Vespri ortodossi a Rivotorto.

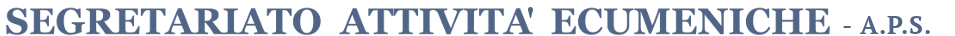
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE