Comunicato stampa n.1
 «Dio pellegrino e accogliente, tu ci insegni che la vera unità si fonda sulla pluralità. Insegnaci ad accoglierci nella diversità e a proteggere chi non è riconosciuto nei suoi diritti e nel suo desiderio di felicità». Le parole oranti dell’indimenticabile Adriana Zarri hanno fatto parte della preghiera del mattino che ha inaugurato alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli (Assisi) la 59ͣa sessione di formazione ecumenica del Sae-aps (Segretariato attività ecumeniche). Circa 180 persone di varie età, provenienze geografiche e chiese hanno risposto all’invito dall’associazione interconfessionale di laiche e laici per l’ecumenismo e il dialogo a partire dal dialogo con l’ebraismo a partecipare all’annuale settimana di studio, riflessione, vita comune su un tema che attraversa le comunità cristiane, sintetizzato nel titolo: “Chiese inclusive per donne nuove e uomini nuovi”.
«Dio pellegrino e accogliente, tu ci insegni che la vera unità si fonda sulla pluralità. Insegnaci ad accoglierci nella diversità e a proteggere chi non è riconosciuto nei suoi diritti e nel suo desiderio di felicità». Le parole oranti dell’indimenticabile Adriana Zarri hanno fatto parte della preghiera del mattino che ha inaugurato alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli (Assisi) la 59ͣa sessione di formazione ecumenica del Sae-aps (Segretariato attività ecumeniche). Circa 180 persone di varie età, provenienze geografiche e chiese hanno risposto all’invito dall’associazione interconfessionale di laiche e laici per l’ecumenismo e il dialogo a partire dal dialogo con l’ebraismo a partecipare all’annuale settimana di studio, riflessione, vita comune su un tema che attraversa le comunità cristiane, sintetizzato nel titolo: “Chiese inclusive per donne nuove e uomini nuovi”.  I lavori sono stati introdotti dagli interventi della presidente, Erica Sfredda, e di Simone Morandini, membro del Comitato esecutivo. Sfredda ha ricordato: «Se siamo qui oggi lo dobbiamo al pensiero e alla fede di una donna, Maria Vingiani, che con visione davvero profetica ha iniziato questa storia bellissima che ora cerchiamo di portare avanti con molta gioia». In un contesto in cui il movimento ecumenico sembrava non avere ancora diritto di cittadinanza e l’incontro pareva impensabile, «Vingiani decise di impegnarsi per costruire un dialogo tra le diverse confessioni cristiane, rispondendo, ne sono certa, alla sua vocazione, cioè a una precisa chiamata del Signore». Ancora oggi, dopo sessant’anni di una storia nella quale le donne hanno potuto esprimersi e sono state valorizzate, il Sae ancora continua il suo discorso di laicità: «uomini e donne adulti, credenti che vivono con piena responsabilità il sacerdozio comune». E vive l’ecumenismo «come stile di vita, stile di ascolto e dialogo che coinvolge tutti e tutte nella quotidianità». Il dialogo che l’associazione cerca di praticare, a partire da quello con il mondo ebraico la cui testimonianza è la radice del cristianesimo, è aperto anche alle altre religioni e al mondo secolarizzato perché «il cristianesimo, nella sua ricerca di testimonianza e di unità, è coinvolto nella prospettiva universale dell’unità della famiglia umana».
I lavori sono stati introdotti dagli interventi della presidente, Erica Sfredda, e di Simone Morandini, membro del Comitato esecutivo. Sfredda ha ricordato: «Se siamo qui oggi lo dobbiamo al pensiero e alla fede di una donna, Maria Vingiani, che con visione davvero profetica ha iniziato questa storia bellissima che ora cerchiamo di portare avanti con molta gioia». In un contesto in cui il movimento ecumenico sembrava non avere ancora diritto di cittadinanza e l’incontro pareva impensabile, «Vingiani decise di impegnarsi per costruire un dialogo tra le diverse confessioni cristiane, rispondendo, ne sono certa, alla sua vocazione, cioè a una precisa chiamata del Signore». Ancora oggi, dopo sessant’anni di una storia nella quale le donne hanno potuto esprimersi e sono state valorizzate, il Sae ancora continua il suo discorso di laicità: «uomini e donne adulti, credenti che vivono con piena responsabilità il sacerdozio comune». E vive l’ecumenismo «come stile di vita, stile di ascolto e dialogo che coinvolge tutti e tutte nella quotidianità». Il dialogo che l’associazione cerca di praticare, a partire da quello con il mondo ebraico la cui testimonianza è la radice del cristianesimo, è aperto anche alle altre religioni e al mondo secolarizzato perché «il cristianesimo, nella sua ricerca di testimonianza e di unità, è coinvolto nella prospettiva universale dell’unità della famiglia umana».
Il tema scelto per la sessione 2023 sugli uomini e le donne, ha continuato la presidente, pone sul tavolo «cosa significhi la differenza di genere nel nostro rapporto con Dio e con la fede», se e come le chiese sono cambiate nel contesto occidentale che è cambiato grazie alle battaglie di donne impegnate e di alcuni uomini, come le chiese si pongono rispetto alle questioni sul genere: le rifiutano aprioristicamente, le recepiscono come temi di tendenza o «hanno scelto la strada stretta e in salita dell’ascolto, del dialogo, di un confronto serio e profondo in un viaggio comune verso la Verità del Signore?». L’ascolto e le discussioni, nei prossimi giorni, saranno accompagnati dalla preghiera e dalle liturgie in un’esperienza performativa nell’offrire strumenti per affrontare le sfide odierne e nel trasformare la vita.
Simone Morandini ha contestualizzato il percorso della sessione includendolo nel cammino ecumenico. Il complesso rapporto Donne, uomini, chiese «è un tema importante per la nostra condizione di credenti, ma anche per il movimento ecumenico, già toccato nelle prime conferenze anche prima del sorgere del Consiglio Ecumenico della Chiese (Cec). Già prima della 1a Assemblea costitutiva di Amsterdam del 1948, infatti, il Cec in formazione era stato chiamato a dimostrare solidarietà con le donne: già era chiaro che l’unità della chiesa poteva essere realizzata solo in una giusta comunità di donne e uomini». Diverse sono le tappe dell’impegno in questo ambito del maggior network mondiale di chiese: a Uppsala nel 1968 venne stigmatizzato il sessismo come male a cui resistere; nel 1975 a Nairobi si poneva l’uguale partecipazione di donne e uomini come obiettivo verso il quale muoversi; il decennio 1988-1998 fu battezzato come Decennio in solidarietà con le donne; il Decennio Superare la violenza, dal 2001 al 2011, attenzionò in specifico sulla violenza sessuale e di genere. Nel 2022 all’Assemblea di Karlsruhe il Cec si è dotato di un codice etico sulla giustizia di genere.
Le riflessioni della sessione su un tema visto come “terra incognita”, ha continuato Morandini, comporta superare delle paure di smarrimento, condizionamenti e strumentalizzazione e chiede di «muovere da alcuni oltrepassamenti teologici: oltre l’androcentrismo e un modello di maschilità macha e virilista, modelli patriarcali di famiglia e di relazioni; un maschile che pretende di essere neutro ed onnicomprensivo; il riferimento all’Uomo e alla Donna come realtà metafisiche di cui si vorrebbe cogliere l’essenza. Parleremo invece di donne e uomini nelle loro storie e nei loro percorsi di vita, nelle loro biografie singolari, intessute di speranze e di fatiche, di amore e di contraddizioni, di relazioni e di conflitti. Oltre una unilaterale declinazione al maschile del pensiero su Dio, oltre la violenza che spesso inquina le relazioni e talvolta ne massacra uno dei partner, guarderemo alla giustizia come parola qualificante e pacificante».  Secondo il teologo «dobbiamo esplorare un tempo di cambiamento profondo, con lo stile di chi non si pone come profeta di sventura, ma cerca di leggere e di interpretare criticamente e in modo articolato la complessità di segni dei tempi. Solo così è possibile comprendere come abitare – personalmente, come chiese, come comunità ecumenica – questo tempo anche nelle sue dinamiche di cambiamento».
Secondo il teologo «dobbiamo esplorare un tempo di cambiamento profondo, con lo stile di chi non si pone come profeta di sventura, ma cerca di leggere e di interpretare criticamente e in modo articolato la complessità di segni dei tempi. Solo così è possibile comprendere come abitare – personalmente, come chiese, come comunità ecumenica – questo tempo anche nelle sue dinamiche di cambiamento».
La mattinata è continuata con il primo panel dal titolo “Ascoltare un tempo di cambiamento” con la filosofa Debora Spini e la teologa Lucia Vantini.

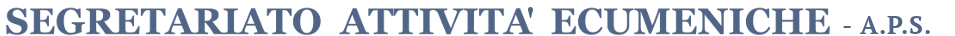
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE