Comunicato stampa n.10
 «Trasmettere la Parola che ci salva, annunciare la buona novella della speranza non è mai facile ma certamente non lo è in modo particolare in tempi di cambiamento sotto molto aspetti: dal clima culturale, al clima meteorologico, al clima delle relazioni tra stati, paesi e culture. In tempi come questo è necessario cambiare anche parole per le nostre chiese, capire quali categorie meglio ci sintonizzano con un tempo nuovo. Come far sì che tali parole lascino trasparire quell’unico grande tesoro che è la Parola che ci salva e ci fonda? Come far trasparire la relazione fondante che ci dona vita, pace e ci convoca come comunità credente?». Da queste domande del teologo cattolico Simone Morandini è partita giovedì alla Sessione Sae di Assisi la tavola rotonda con tre figure “storiche” e affezionate all’associazione: il teologo valdese Fulvio Ferrario, il presbitero ortodosso romeno Traian Valdman e la teologa cattolica Cettina Militello – questa in collegamento da Palermo –.
«Trasmettere la Parola che ci salva, annunciare la buona novella della speranza non è mai facile ma certamente non lo è in modo particolare in tempi di cambiamento sotto molto aspetti: dal clima culturale, al clima meteorologico, al clima delle relazioni tra stati, paesi e culture. In tempi come questo è necessario cambiare anche parole per le nostre chiese, capire quali categorie meglio ci sintonizzano con un tempo nuovo. Come far sì che tali parole lascino trasparire quell’unico grande tesoro che è la Parola che ci salva e ci fonda? Come far trasparire la relazione fondante che ci dona vita, pace e ci convoca come comunità credente?». Da queste domande del teologo cattolico Simone Morandini è partita giovedì alla Sessione Sae di Assisi la tavola rotonda con tre figure “storiche” e affezionate all’associazione: il teologo valdese Fulvio Ferrario, il presbitero ortodosso romeno Traian Valdman e la teologa cattolica Cettina Militello – questa in collegamento da Palermo –.
Fulvio Ferrario, docente di teologia sistematica alla Facoltà valdese di teologia di Roma, in un originale percorso ha deciso di tematizzare tre parole antiche di cui ha sostenuto il carattere inevitabilmente insostituibile parlando, ha specificato, «dal punto di vista di un uomo cristiano di una chiesa occidentale non specificamente protestante».
 La prima parola affrontata è “Dio” che «ha il suo posto in tanti discorsi ma è molto meno ovvia di quanto appaia». C’è chi, come il religioso e poeta svizzero Kurt Marti, di cui Ferrario è traduttore con Berta Ravasi per la Claudiana, ha evidenziato attraverso un testo lirico la “passione” della parola “Dio”: «torturata, disintegrata, ridotta a protesi, l’ultima delle parole, la proletaria del linguaggio». Ferrario riconosce che «anche nei “professionisti” di Dio esiste una tentazione dell’ovvietà della parola anche in una variante religiosa e teologica. Ci sarebbero ragioni per invitare a una sostenuta sobrietà nel suo uso. Secondo il relatore, il teologo Hans-Martin Barth condivide, radicalizzate, le preoccupazioni che furono del pastore Dietrich Bonhoeffer: la parola Dio è consumata dalla religione e dall’ateismo. Per evitare il logoramento Hans-Martin Barth ha inventato parole nuove per dire Dio, come “fondamento creativo e scopo di ogni vita” o “mistero della vita”». Dal canto suo Ferrario dice di voler continuare a usare la parola Dio perché «quando dico Dio evoco una storia, non solo la storia biblica, ma la storia delle chiese, delle persecuzioni. Non si può togliere Dio da questa storia. La fede non vive di concetti ma di una narrazione fondamentale e delle narrazioni che essa ha evocato».
La prima parola affrontata è “Dio” che «ha il suo posto in tanti discorsi ma è molto meno ovvia di quanto appaia». C’è chi, come il religioso e poeta svizzero Kurt Marti, di cui Ferrario è traduttore con Berta Ravasi per la Claudiana, ha evidenziato attraverso un testo lirico la “passione” della parola “Dio”: «torturata, disintegrata, ridotta a protesi, l’ultima delle parole, la proletaria del linguaggio». Ferrario riconosce che «anche nei “professionisti” di Dio esiste una tentazione dell’ovvietà della parola anche in una variante religiosa e teologica. Ci sarebbero ragioni per invitare a una sostenuta sobrietà nel suo uso. Secondo il relatore, il teologo Hans-Martin Barth condivide, radicalizzate, le preoccupazioni che furono del pastore Dietrich Bonhoeffer: la parola Dio è consumata dalla religione e dall’ateismo. Per evitare il logoramento Hans-Martin Barth ha inventato parole nuove per dire Dio, come “fondamento creativo e scopo di ogni vita” o “mistero della vita”». Dal canto suo Ferrario dice di voler continuare a usare la parola Dio perché «quando dico Dio evoco una storia, non solo la storia biblica, ma la storia delle chiese, delle persecuzioni. Non si può togliere Dio da questa storia. La fede non vive di concetti ma di una narrazione fondamentale e delle narrazioni che essa ha evocato».
Un’altra parola antica a cui Ferrario è fedele è la parola “croce” perché «è una parola centrale: parla dell’amore di Dio. Allora perché non dico amore? Perché la croce libera dall’ambiguità della parola “amore”. Paolo può parlare di tutta la storia dicendo la parola della croce. Io non riesco a farne a meno». Infine, riguardo alla terza parola scelta, “salvezza”, il docente della Facoltà valdese dice la problematicità di declinare ai catecumeni di oggi tale concetto. Come parlare di salvezza? Salvezza da che cosa? Un conto è affermare di avere una pista di riflessione sul senso della vita, ma non si tratta della stessa cosa rispetto all’annuncio della salvezza. «Il termine salvezza è centralissimo e nello stesso tempo problematico», ha concluso Ferrario che ha suscitato domande su questo tema.
Traian Valdman si è mosso su tre temi-parole: “Dio”, “l’uomo”, “la chiesa”. «Vorrei portare speranza con parole di fede – ha detto –. Siamo chiamati a conoscere i problemi dei nostri contemporanei per trovare le parole che possono annunciare la buona novella. Le parole della fede ci guidano a superare difficoltà non solo storiche e sociali ma anche spirituali. Sono risposte alle esigenze di ogni persona del nostro tempo e testimonianza di qualcosa che abbiamo vissuto».
Il presbitero ortodosso ha sottolineato che «Dio è un essere che si rivela parlando al singolare e al plurale. La Bibbia ci dice non chi è ma cosa fa Dio. Il “noi” di Dio evoca una storia, vive con noi, ci libera dall’Egitto. Sulla croce Gesù inocula nella natura umana la possibilità di dire sì alla volontà di Dio». Proseguendo, Valdman ha detto di ritenere importante parlare di Dio come comunione e come fondamento di ogni comunione. «Dio è amore e si manifesta come amore capace di sacrificarsi. La crocefissione e la risurrezione sono un unico mistero». Ha poi analizzato il termine “uomo” alla luce della creazione, dell’incarnazione e dell’ascensione. Egli è a immagine di Dio e collaboratore di Dio. Il servizio è lo stile di vita del cristiano e di ogni uomo. La chiesa è luogo di incontro tra Dio e l’umanità, è icona della Trinità, è il corpo di Cristo esteso nell’umanità. Fare esperienza di Gesù porta a vivere la testimonianza su di lui. Il presbitero ha citato l’esperienza ecumenica dell’accoglienza dei cristiani praticata in Grecia che manifesta il realismo possibile della testimonianza comune ecumenica».
Cettina Militello ha messo in luce che la crisi investe i valori e i modelli nella famiglia, nella politica e nelle chiese dove sono messi in discussione i modelli di leadership e di appartenenza. «E, ciò malgrado, la crisi è sempre sfida, opportunità, passaggio obbligato verso il nuovo. Nuovi valori, nuovi modelli, nuove istituzioni». La teologa è convinta che occorre celermente operare una riforma se davvero si vuole che le comunità cristiane abbiano un futuro. «Mi muovo nel segno della speranza, nella traiettoria di un futuro possibile, di un regno di Dio la cui salvezza incrocia la nostra storia finalmente aprendo scenari nuovi, definitivamente contrassegnati da solidarietà, empatia, compassione, fiducia». La sfida è «restituire il deposito della fede alla sua essenzialità, per altro non divisiva, e, insieme, riconoscere come la sua traduzione verbale sia stata sempre e comunque debitrice alla cultura». Riconoscere questo significa per Militello «affrettare quanto più possibile il ritorno all’essenziale, al deposito, al kerygma nella sua forma più essenziale, lasciando così aperta la possibilità inedita e nuova di ridirlo per il nostro tempo».

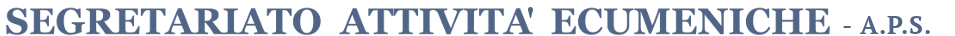
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE