Comunicato stampa n.10
 Il dialogo interreligioso è una prospettiva che il Sae ha sempre tenuto presente sullo sfondo della sua storia. Alcune sessioni alla fine degli anni ’90 sono state dedicate al tema e ogni anno esso è declinato attraverso un momento specifico di confronto con uomini e donne di altre tradizioni. La tavola rotonda interreligiosa della 59a edizione – intitolata “Per la giustizia di genere” – ha avuto come ospiti Paola Cavallari, Sarah Kaminski e Zineb Moujoud che, nella loro visione singolare, hanno trattato il tema da una prospettiva cristiana, ebraica e islamica a partire da tre parole: differenza-uguaglianza, storia-memoria, sessismo.
Il dialogo interreligioso è una prospettiva che il Sae ha sempre tenuto presente sullo sfondo della sua storia. Alcune sessioni alla fine degli anni ’90 sono state dedicate al tema e ogni anno esso è declinato attraverso un momento specifico di confronto con uomini e donne di altre tradizioni. La tavola rotonda interreligiosa della 59a edizione – intitolata “Per la giustizia di genere” – ha avuto come ospiti Paola Cavallari, Sarah Kaminski e Zineb Moujoud che, nella loro visione singolare, hanno trattato il tema da una prospettiva cristiana, ebraica e islamica a partire da tre parole: differenza-uguaglianza, storia-memoria, sessismo.
«Siamo ancora lontani dall’aver raggiunto l’obiettivo di una giustizia di genere – ha premesso il teologo e scrittore Brunetto Salvarani, che ha moderato i lavori –. La violenza costituisce una questione strutturale, un flagello che rappresenta la prima causa di morte delle donne. Esse sono sottorappresentate nei ruoli di comando, guadagnano meno degli uomini e sono le prime a perdere il lavoro nei tempi di crisi. Il cambiamento necessario inizia con nuovi modi di pensare. Come diceva Bergonzoni: “Non dovremmo solo rimboccarci le maniche ma soprattutto il pensiero”». Il teologo ha citato come esempio di buona pratica il documento sulla giustizia di genere della Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi) promosso e votato nel 2021 durante il 23° Sinodo. Il testo afferma che «è necessario riconoscere il dono di ogni persona e il suo valore di donna, uomo e persona non binaria. Da un discorso di giustizia di genere trae vantaggio tutta la comunità, mentre quando una persona è discriminata tutta la comunità è danneggiata».
Entrando nel merito del binomio differenza-uguaglianza, secondo Sarah Kaminski, scrittrice, traduttrice, docente all’Università di Torino, «la questione della coppia e delle parole dialettiche che si completano l’un l’altra è insita in noi. Nel racconto della creazione del mondo, incontriamo il “vizio” ebraico di iniziare dalle due creazioni, dalla separazione. Per me la cosa più importante è la divisione, che dà diritto a un’esistenza autonoma, completa ma complementare».
La docente ha portato degli esempi di lettura, dicendo che occorre cautela nel leggere la Bibbia. Nel primo racconto della creazione (Gen 1,27): «“Dio disse “faremo l’uomo nella nostra immagine, nel nostro modo di essere”. Chi sono i noi? Il midrash dice che Dio ha discusso con gli angeli e ha cancellato i volti precedenti perché non gli piacevano. Ha creato nella sua immagine, e non vado a discutere la questione di Dio femminile. Per me è un insieme di identità, del tutto astratto. C’è scritto: ha creato nella sua immagine, maschio e femmina. Due parole in tensione e in armonia».
Passando poi al secondo racconto (Gen 2,18), Kaminski propone una traduzione alternativa per l’affermazione divina che è generalmente tradotta “Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. «Il termine utilizzato è ezer kenegdo: un aiuto “contro” di lui, in dialettica con lui, a complemento di lui. I rabbini discutono il fatto che la donna può essere un aiuto per l’uomo, ma può essere anche un elemento in opposizione assoluta a lui. Grossman spiega che in tutta la storia ebraica le donne ufficialmente avevano uno status minoritario, ma c’erano lettere e documenti in cui gli uomini si lamentavano del potere delle donne a casa e della loro gestione degli affari. Le definiscono ribelli e sfacciate. In teoria erano minoritarie, di fatto le donne valevano».
Paola Cavallari, cattolica, insegnante, fondatrice e presidente emerita dell’Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne, ha premesso che ci sono due modi per intendere la parola differenza: uno positivo e uno negativo; uno orizzontale e uno gerarchico. Il femminismo della differenza ha elaborato da anni un pensiero sulla differenza nell’accezione positiva. «Anche il termine uguaglianza è importante, e sarebbe meglio declinarla come parità: abbiamo bisogno di pari diritti, un pari accesso al voto e ai servizi pubblici. Il pensiero della differenza ha superato il traguardo dell’uguaglianza che era stata interpretata spesso come assimilazione. L’accesso delle donne a determinate leadership e ruoli di potere non sia una estensione dei diritti già dati ma una rifondazione dei diritti a partire dalle differenze».
Entrando nel discorso del magistero della Chiesa cattolica, Cavallari ha citato una rivisitazione della Mulieris dignitatem fatta da papa Francesco nel 2013 nella quale si parla di uno “speciale affidamento” dell’essere umano alla donna nella maternità. Commenta l’insegnante: «Questa spia linguistica forse poco visibile immediatamente, fa cogliere come ancora si possa vivere la dimensione dell’umano come se la donna fosse estranea all’umano. Una conseguenza di questa allocuzione riguarda il principio petrino e il principio mariano. Il genio femminile è stato molto inneggiato. Ci chiediamo come donne perché il genio femminile deve avere caratteristiche specifiche nell’ambito dell’essere cristiani e non avere caratteristiche che sono trasversali a tutti gli uomini e le donne: la misericordia, la dolcezza, l’amore, la carità. Si ha l’impressione che per le donne ci sia un posto speciale che è però un piccolo recinto che non apre alla libertà, nel quale il genio femminile può agire solo nei termini della maternità. Maternità è un’enorme potenzialità della donna ma è una funzione. La Chiesa cattolica l’ha interpretata come controllo sulla riproduzione e sulla sessualità femminile».
Zineb Moujoud, della Comunità islamica di Perugia, futura psicologa, impegnata nel dialogo interreligioso, sul tema differenza-uguaglianza ricorda un campo estivo di giovani cristiani in cui una ragazza le aveva rivolto una domanda sulla posizione religiosa della donna nell’Islam. «Il campeggio era focalizzato su una figura ponte, Maria, una maestra di fede anche per noi, della quale il Corano racconta la nascita. In questo episodio la mamma di Maria era fiduciosa che ciò che portava in grembo fosse un maschio e lo avrebbe consacrato al Signore. Dopo aver partorito disse “ho partorito una femmina, il maschio non era certo uguale alla femmina”. Il maschio aveva l’accesso esclusivo al tempio. Ma Dio ha accolto Maria e l’ha fatta crescere. Spesso siamo noi che leggiamo la religione in termini discriminatori tra maschio e femmina. La mamma di Maria era convinta della superiorità del maschio, ma Dio ha accettato Maria che è stata l’unico caso femminile all’interno del tempio ed è diventata una figura di essere umano purificato che si dedica completamente a Dio».
Secondo Moujoud è importante per la comprensione delle dinamiche di differenza e uguaglianza tra generi in una cornice religiosa «distinguere quelli che sono la cultura, l’educazione, la tradizione da quelli che sono gli insegnamenti religiosi. La tradizione e la cultura in cui siamo tanto inseriti ci dà i paraocchi con i quali leggiamo anche la religione. Nel Corano uomini e donne sono sullo stesso piano; negli elenchi si utilizza il maschile e il femminile».
Rispetto al binomio storia/memoria Kaminski distingue due atteggiamenti nell’ebraismo contemporaneo: la società ebraica ortodossa e ultraortodossa sta rinnovando momenti che dall’illuminismo in poi le donne all’interno dell’ebraismo hanno ottenuto o hanno ripescato e hanno fatto riconoscere dal mondo maschile, e il mondo intero ebraico, visibile nei serial televisivi e nei film, che sta facendo riguardo alle donne dei passi indietro.
Sulla memoria, che nella lingua ebraica è un termine maschile - zachor, zachar - da una generazione all’altra si rimuovono le donne. «Le donne sono una memoria narrata all’interno della casa sino a una certa età, poi negli scritti e nei commenti cessano di essere un elemento importante. La memoria va attuata dalle donne in due momenti basilari della memoria ebraica. Il primo è Shabbat, “luogo” che accoglie l’emanazione femminile di Dio, la Shekhinah, ma il ruolo delle donne si ferma alla soglia di Shabbat, alla sera. Lei è molto presente, ma da lì in poi le normative sono riferite all’uomo. Il secondo momento è Pesach, la Pasqua ebraica, dove la preparazione della festa è affidata alle mani della donna, ma la conduzione del Seder sarà affidata all’uomo. La legge ebraica dice che sono momenti importanti perché non si deve solo ricordare ma custodire (shomer). Il momento dello zachor e shomer, le due candele per accogliere lo Shabbat, è tramandato attraverso le donne. Dal 1920 nella terra d’Israele le donne hanno il diritto al voto ma tante storiche dimostrano che le donne sono finite poi in cucina. Ci volevano gli anni ’80 per dare uguaglianza agli stipendi, ai posti di lavoro, nella politica».
Paola Cavallari osserva che nell’ambito della storia-memoria e degli altri saperi, la realtà è interpretata da diversi punti di vista che non possono essere ignorati. «Esistono delle parzialità che si rifanno a razza, etnia, religione, sesso, genere. Ci sono uomini che stanno affrontando la loro posizione come soggetto sessuato, non più come uomo in senso neutrale. Anche la donna è soggetto sessuale. Entrambi pensano la loro storia e identità di genere con la consapevolezza che non sono l’intero».
Come Kaminski, Cavallari riprende la nuova traduzione di Genesi 2,18 “un soccorso contro di lui”: «contro, di fronte, è il volto dell’altro che resiste alla nostra autosufficienza, al nostro desiderio di non incontrare ostacoli, il limite. La ricchezza che ci offre questa formulazione è immensa. A parte il fatto che in Genesi si dice che Dio creò l’Adam dalla Adamà, che non è l’uomo, ma il terroso, l’essere umano, la prima creazione, e poi avviene lo sdoppiamento sessuato. Sappiamo quali ricadute hanno le traduzioni di certi testi del Primo sul Nuovo Testamento».
Per parlare della giustizia di genere nell’Islam, Zineb Moujoud è partita dalla realtà antica nella penisola araba. «L’arrivo di una neonata femmina era un evento vergognoso, catastrofico, per questo era seppellita viva dal suo stesso padre. Dio nel Corano condanna fermamente questa pratica atroce. Il modello maschilista viene completamente sconvolto dal messaggio rivoluzionario dell’Islam che riconosce il diritto alla vita delle donne, che a noi pare scontato. Qualche secolo fa non lo era. Il Corano riconosce il diritto alla vita, alla cura, all’educazione, all’istruzione, all’affetto, alla pietà, alla tenerezza, all’eredità. Nel VII secolo una donna gestiva un grande mercato. Le donne si sono oggi affermate in campo ingegneristico, artistico, sportivo. Nel 2019 avete eletta a ricoprire il ruolo di giovane europea una giovane musulmana velata italiana, tutti questi esempi sono piccoli flash per fare vedere come - da essere seppellita viva, ad avere diritti, a emergere nella società come protagonista - la donna ha fatto un percorso e la religione dell’infanzia l’ha favorita in questo suo sviluppo. Lottare per i diritti della donna in alcuni contesti sociali di maggioranza islamica è un grande paradosso che riflette come il binomio religione e tradizioni culturali spesso siano confusi e contaminati l’un l’altro».
L’ultima parola, sessismo, è analizzata da Sarah Kaminski premettendo che il modello dell’ebraismo è patriarcale. «Il popolo Israele è femmina. Una delle definizioni correnti nella Bibbia per dire il suo peccato è affermare che è un popolo che si prostituisce. Questo è offensivo, e non si parla mai di prostituzione maschile. Gli uomini ebrei erano oggetto di sessismo essendo considerati effeminati perché non facevano il mestiere di contadino o guerriero. Con l’illuminismo e con la rivoluzione sionista la donna diventata pioniera, contadina e anche soldata. Ma è stato solo dagli anni ’80 in poi che la donna ha avuto lo status che ha oggi in Israele di cui sono molto fiera, ma non sono fiera di quello che c’è negli ambienti religiosi. Nella società israeliana oggi viene affrontato il tema dei diritti agli omosessuali e a persone di ogni orientamento; in quanto a leggi dello Stato siamo avanti. L’adozione e l’utero in affitto sono accettati e garantiti dalla legge israeliana. Non così la pensano gli ambienti religiosi e ultrareligiosi: è un’altra storia che va raccontata in un altro modo».
Il termine sessista, secondo Paola Cavallari, «è molto sfuggente: a prima vista non si riconosce se una società è sessista. La citazione di papa Francesco era sessista. È facile a dirsi ma difficile ad afferrarlo. Ci sono categorie concettuali che veicolano il sessismo (spirito-materia, ragione-sentimenti, anima-corpo, attivo-passivo, forte-debole, astratto-concreto, teorico-empirico, trascendente-immanente, cultura- natura) ma è difficile rendersene conto. Non sono poli oppositivi che hanno lo stesso valore assiologico, ad esempio il corpo era considerato inferiore rispetto allo spirito».
La scrittrice ricorda l’Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne, «filiazione del Sae, che è nato anche perché nel 2015 ci fu un Appello di dieci Chiese cristiane che chiedeva alle Chiese in Italia di farsi carico della violenza sulle donne: vogliamo ricordarci di questa cosa, vogliamo impegnarci nel portarla avanti? Il pastore valdese Daniele Bouchard, che dice di aver imparato che la violenza è costitutiva del genere maschile, ha scritto che “le chiese cristiane hanno la possibilità e la responsabilità di intervenire contro la violenza sulle donne a diversi livelli. Qualche passo in avanti è stato fatto, ne è un esempio l’Appello del 2015, ma è ancora troppo difficile parlare di violenza sulle donne negli ambienti ecclesiastici. Riconoscere che il problema della violenza è anche interno alle chiese significa ammettere che le chiese sono parte costitutiva del patriarcato, e dunque sono corresponsabili anche della violenza maschile. È risaputo che il luogo dove avviene la maggior parte delle violenze sulle donne è la famiglia. La cristianità non ha nessuna responsabilità in questo?”».
Anche per Zineb Moujoud il sessismo è facile da dire e difficile da afferrare. Infatti «l’atteggiamento di difendere certi atteggiamenti spesso non avviene in modo consapevole. A volte sono le stesse donne che si sottomettono in modo incondizionato agli atti di discriminazione nei loro confronti considerandoli normali perché loro sono donne. Addirittura può capitare che anche in contesti islamici diventano protagoniste di approcci sessisti verso i loro simili, per quanto riguarda l’istruzione è spesso la mamma che impedisce alla figlia di continuare a studiare perché “è roba da maschio”. Oppure succede che l’uomo quando arriva a casa deve trovare il cibo caldo. Ma non accade il contrario. C’è distanza tra questi atteggiamenti e l’insegnamento islamico. Il Profeta era su un’altra linea. Si faceva consigliare anche politicamente da una giurista musulmana. In un’ottica islamica uomo e donna sono creati da un solo essere. Ci saranno ruoli, abilità, responsabilità specifiche, ma non dicono superiorità o inferiorità bensì differenze complementari, collaborazione tra generi piuttosto che competizione».
La tavola rotonda si è conclusa con tre appelli all’assemblea richiesti dal moderatore. Paola Cavallari ha auspicato che i temi delle prossime sessioni tengano presente il pensiero sessuato. Zineb Moujoud ha chiesto di continuare sulla linea di conoscere l’altro, proporre la realtà dalla parte dei due generi, lavorare in sintonia. Sarah Kaminski ha suggerito di studiare diversamente l’ebraismo. «Trovo in moltissimi ambienti una conoscenza superficiale e l’ignoranza della storia ebraica e di Israele oggi».

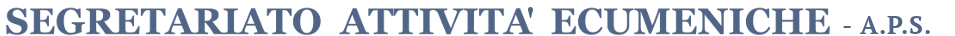
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE