Comunicato stampa n.5
Per un linguaggio non sessista: Come parliamo di Dio? È la domanda alla base della tavola rotonda di martedì alla sessione Sae di Assisi nella quale cristiane e cristiani di diverse confessioni stanno interrogandosi su come costruire chiese più accoglienti, capaci di accogliere le diversità, e prima di tutto la diversità di genere.
 «La domanda su come dire Dio riguarda la nostra identità di credenti e non solo i teologi e le teologhe - ha detto in apertura la pastora battista Lidia Maggi, impegnata nel dialogo ecumenico e interreligioso e membro del gruppo teologico del Sae -. Ci interroghiamo perché abbiamo prestato attenzione alle voci che sorgono nel contesto in cui siamo chiamate e chiamati a vivere la nostra fede. Voci creative che ci hanno mostrato che è possibile un altro linguaggio per dire Dio, che facciamo teologia in una situazione nella quale tra le varie crisi che affrontiamo - la crisi della parola, di un linguaggio di fede che sembra non comunicare più - c’è una parte di chiesa che si sente esclusa da un certo modo di dire Dio». La riflessione sul linguaggio, precisa Maggi, riguarda tutto il simbolico che la grammatica e la lingua mettono in scena. E riguarda come fare liturgia, come testimoniare, come essere Chiesa. Questo ripensamento viene svolto in un contesto ecumenico alla cui radice c’è la responsabilità che la chiesa sia sempre più una realtà inclusiva dove le differenze siano accolte e riconosciute. La vocazione specifica ecumenica, aggiunge la biblista, «è proprio quella di interrogarsi sulle ferite tra e nelle chiese, e provare a facilitare processi di giustizia riparativa».
«La domanda su come dire Dio riguarda la nostra identità di credenti e non solo i teologi e le teologhe - ha detto in apertura la pastora battista Lidia Maggi, impegnata nel dialogo ecumenico e interreligioso e membro del gruppo teologico del Sae -. Ci interroghiamo perché abbiamo prestato attenzione alle voci che sorgono nel contesto in cui siamo chiamate e chiamati a vivere la nostra fede. Voci creative che ci hanno mostrato che è possibile un altro linguaggio per dire Dio, che facciamo teologia in una situazione nella quale tra le varie crisi che affrontiamo - la crisi della parola, di un linguaggio di fede che sembra non comunicare più - c’è una parte di chiesa che si sente esclusa da un certo modo di dire Dio». La riflessione sul linguaggio, precisa Maggi, riguarda tutto il simbolico che la grammatica e la lingua mettono in scena. E riguarda come fare liturgia, come testimoniare, come essere Chiesa. Questo ripensamento viene svolto in un contesto ecumenico alla cui radice c’è la responsabilità che la chiesa sia sempre più una realtà inclusiva dove le differenze siano accolte e riconosciute. La vocazione specifica ecumenica, aggiunge la biblista, «è proprio quella di interrogarsi sulle ferite tra e nelle chiese, e provare a facilitare processi di giustizia riparativa».
Un altro motivo per dire Dio in un linguaggio non sessista «è l’eccedenza che richiede una ricerca esistenziale per dire l’esperienza strepitosa che è stato Dio per noi. Se siamo qui è perché diciamo che la nostra speranza è il Dio della vita che vogliamo dire con una lingua altra per imparare una grammatica diversa da quella del faraone. Siamo qui perché Dio ha un presente e un futuro, una storia che cerca nuovi linguaggi per nuove stagioni. Risuoni la capacità di dire Dio con tutti i nostri diversi registri. Se saremo capaci, sarà possibile imparare a praticare una lingua altra che ci strapperà ai vari esili, anche a quello del patriarcato».
 Per il presbitero ortodosso russo, Vladimir Zelinsky, in Italia da diversi decenni, anch’egli membro del gruppo teologico del Sae, il problema del linguaggio per dire Dio semplicemente non esiste nell’Ortodossia. «Nella società occidentale come anche nella cristianità spesso è comparsa la volontà di giudicare, a volte processare il proprio passato, incluso il nostro linguaggio religioso. Se nel passato si possono trovare tanti peccati e addirittura crimini, e quanto il nostro linguaggio ha rappresentato il disprezzo delle donne e la loro umiliazione, prima di condannare dobbiamo chiedere chi è il giudice che può perdonare o assolvere. Credo che il giudice sia la coscienza moderna che si rinnova sempre, che si scopre sempre di nuovo. L’uomo modifica la propria fede sulla base delle rinnovate evidenze e vicende che il mondo ci rimanda con la sua trasformazione permanente». Per Zelinsky è abbastanza difficile immaginare situazioni simili a nominare Dio in un linguaggio non sessista in una confessione basata principalmente sulla Tradizione patristica dei primi secoli dopo Cristo. Spiega il suo pensiero citando un’esperienza all’interno del gruppo teologico del Sae rispetto alla discussione sul sacerdozio femminile. «Insieme più o meno siamo arrivati alla conclusione che non ci sono argomenti scritturistici e teologici validi che dovrebbero impedire le ordinazioni delle donne. Non ci sono, non dovrebbero esserci. Per i fratelli e le sorelle protestanti non c’è più il problema. Per i cattolici invece sì, sono spesso sulle difensive perché devono giustificare la propria resistenza a tali ordinazioni. Gli ortodossi di solito non partecipano a questa battaglia, ma osservano da una certa distanza. Se l’assillo non si presenta, perché dovrebbero difendere ciò che non è ancora sentito neanche come provocazione? Nel momento attuale le donne ortodosse in maggioranza non accetterebbero il sacerdozio femminile. Se non ci sono argomenti contro, non ci sono neanche a favore. L’unico motivo fondamentale è che il pensiero teologico si è aperto ai diritti umani portati dalla società moderna. Questo concetto non c’è nella spiritualità ortodossa, l’uomo non ha diritti davanti a Dio. La risposta giusta a questa e ad altre sfide del genere sarebbe il silenzio, solenne, pieno di conversione».
Per il presbitero ortodosso russo, Vladimir Zelinsky, in Italia da diversi decenni, anch’egli membro del gruppo teologico del Sae, il problema del linguaggio per dire Dio semplicemente non esiste nell’Ortodossia. «Nella società occidentale come anche nella cristianità spesso è comparsa la volontà di giudicare, a volte processare il proprio passato, incluso il nostro linguaggio religioso. Se nel passato si possono trovare tanti peccati e addirittura crimini, e quanto il nostro linguaggio ha rappresentato il disprezzo delle donne e la loro umiliazione, prima di condannare dobbiamo chiedere chi è il giudice che può perdonare o assolvere. Credo che il giudice sia la coscienza moderna che si rinnova sempre, che si scopre sempre di nuovo. L’uomo modifica la propria fede sulla base delle rinnovate evidenze e vicende che il mondo ci rimanda con la sua trasformazione permanente». Per Zelinsky è abbastanza difficile immaginare situazioni simili a nominare Dio in un linguaggio non sessista in una confessione basata principalmente sulla Tradizione patristica dei primi secoli dopo Cristo. Spiega il suo pensiero citando un’esperienza all’interno del gruppo teologico del Sae rispetto alla discussione sul sacerdozio femminile. «Insieme più o meno siamo arrivati alla conclusione che non ci sono argomenti scritturistici e teologici validi che dovrebbero impedire le ordinazioni delle donne. Non ci sono, non dovrebbero esserci. Per i fratelli e le sorelle protestanti non c’è più il problema. Per i cattolici invece sì, sono spesso sulle difensive perché devono giustificare la propria resistenza a tali ordinazioni. Gli ortodossi di solito non partecipano a questa battaglia, ma osservano da una certa distanza. Se l’assillo non si presenta, perché dovrebbero difendere ciò che non è ancora sentito neanche come provocazione? Nel momento attuale le donne ortodosse in maggioranza non accetterebbero il sacerdozio femminile. Se non ci sono argomenti contro, non ci sono neanche a favore. L’unico motivo fondamentale è che il pensiero teologico si è aperto ai diritti umani portati dalla società moderna. Questo concetto non c’è nella spiritualità ortodossa, l’uomo non ha diritti davanti a Dio. La risposta giusta a questa e ad altre sfide del genere sarebbe il silenzio, solenne, pieno di conversione».
 Per la teologa cattolica Marinella Perroni, fondatrice del Coordinamento delle teologhe italiane, il Sae rappresenta «un’icona di come amerei che si esprimesse l’unica chiesa cristiana capace di dialogare con le altre religioni perché finalmente ha accettato la dinamica della pluralità delle voci cristiane al suo interno». Al suo discorso ha premesso affermazioni di Elena Loewenthal su cui si sente in sintonia e che ha definito «un bel lasciapassare per questa sessione». Scrive Loewenthal: «Tutto è più fluido oggi anche in questo mondo, lo spazio della fede è sempre più variegato e propenso a riconoscere e rispettare ed accogliere le differenze. Una società multicolore è anche multiconfessionale. Ma non c’è dialogo interreligioso che tenga se prima non si stabilisce un’agenda comune sul femminile. Su come poter cambiare uno status quo atavico senza sovvertire tutto il resto, perché come dice il Talmud “non c’è tradizione senza novità”. Per dare voce e parola alle donne nell’universo religioso bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo, solo andando alle origini, a quelle fonti sulle quali, e malgrado le quali, si è costruita l’emarginazione».
Per la teologa cattolica Marinella Perroni, fondatrice del Coordinamento delle teologhe italiane, il Sae rappresenta «un’icona di come amerei che si esprimesse l’unica chiesa cristiana capace di dialogare con le altre religioni perché finalmente ha accettato la dinamica della pluralità delle voci cristiane al suo interno». Al suo discorso ha premesso affermazioni di Elena Loewenthal su cui si sente in sintonia e che ha definito «un bel lasciapassare per questa sessione». Scrive Loewenthal: «Tutto è più fluido oggi anche in questo mondo, lo spazio della fede è sempre più variegato e propenso a riconoscere e rispettare ed accogliere le differenze. Una società multicolore è anche multiconfessionale. Ma non c’è dialogo interreligioso che tenga se prima non si stabilisce un’agenda comune sul femminile. Su come poter cambiare uno status quo atavico senza sovvertire tutto il resto, perché come dice il Talmud “non c’è tradizione senza novità”. Per dare voce e parola alle donne nell’universo religioso bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo, solo andando alle origini, a quelle fonti sulle quali, e malgrado le quali, si è costruita l’emarginazione».
Secondo Perroni la questione del linguaggio su Dio è estremamente complessa. «Il parlare di o su Dio ha sempre utilizzato i linguaggi umani ed è sempre espressione e frutto del multilinguismo. «Babele è inscritta nella Rivelazione molto più di quanto facili moralismi ci consentano di ammettere. Se noi ci interroghiamo sul sessismo del nostro parlare di Dio cediamo alla tendenza del momento storico nel quale viviamo, cediamo al linguaggio civile, ma abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di farlo. Ce lo chiede la storia, gli uomini e le donne e soprattutto le generazioni future. Perché oggi il soggetto pensante ed ermeneutico della Rivelazione biblica ha acquisito la consapevolezza di essere intersezionale, la consapevolezza delle sue diverse determinazioni tra le quali quella della sessuazione. Si tratta di una consapevolezza individuale ma anche collettiva, a forte valenza politica».
Un libro del 1995 - Le donne dicono Dio. Quale Dio dicono le donne? E Dio dice le donne? - ha offerto spunti alla teologa per sviluppare il suo discorso. «Io credo – dice Perroni - che si può dire che Dio ha il volto di chi lo racconta. Il Dio biblico è il Dio raccontato, che si consegna ai linguaggi e alle narrazioni e alla storia. Il Dio delle donne è un Dio diverso. La Rivelazione dice che Dio è di chi lo dice, non esiste al di fuori del suo dirsi, ma il suo dirsi è all’interno dei linguaggi degli uomini e delle donne che in qualche modo ne hanno fatto esperienza. La Bibbia è una raccolta di parole e di silenzi, di pensieri e di azioni di uomini e donne che hanno permesso a Dio di dirsi».
Commentando il terzo stico del titolo – Dio dice le donne – la teologa afferma che la Rivelazione parla di donne, si consegna a donne. Nel vangelo di Giovanni, strutturato intorno a figure femminili e alle teologie che esprimono, Gesù si rivolge con l’appellativo “donna” anche alla donna sorpresa in flagrante adulterio, anonima ma rappresentativa della condizione prevista per le donne all’interno di un preciso sistema socio-religioso. Mentre le parole di Gesù raggiungono il cuore di una donna vittima di un’ideologia religiosa tanto feroce quanto ingiusta, chiudono con sovrana autorevolezza anche un contenzioso nel quale volevano trascinarlo i suoi avversari. Difficile supporre che fosse stata colta in flagrante adulterio solo la donna, osserva Perroni. Quindi è evidente che al centro dell’interesse degli accusatori c’era la pretesa di affermare il diritto di proprietà sulle donne, pretesa messa in discussione da Gesù. Non si tratta di negare la gravità di un adulterio radicato spesso in precise colpe ma non sempre imputabile solo a chi lo compie. Si tratta di pronunciare una parola di misericordia potente ed efficace.
 In particolare nei paesi latini il mito delle figlie di Eva persiste, osserva la teologa, ed è causa di violenza e dolori, femminicidi e processi per stupro. Le donne sono imputate permanenti e riconosciute sempre come causa prima. Poco importa se attraggono o respingono perché la diversità sessuale è vissuta come luogo antropologico di ogni provocazione. Conclude: «Il Cristo giovanneo che dice “donna” ha ancora molto da insegnare alle nostre chiese e alle società che esse hanno contribuito a forgiare. Sento pressante, rispetto al nostro dire Dio con le parole, i gesti e le scelte, il monito di Gesù: “Voi siete obbedienti più alle tradizioni dei padri che al comando di Dio”. E spero che tra cent’anni si possa ammonire di non essere più obbedienti alla tradizione delle madri che al comando di Dio».
In particolare nei paesi latini il mito delle figlie di Eva persiste, osserva la teologa, ed è causa di violenza e dolori, femminicidi e processi per stupro. Le donne sono imputate permanenti e riconosciute sempre come causa prima. Poco importa se attraggono o respingono perché la diversità sessuale è vissuta come luogo antropologico di ogni provocazione. Conclude: «Il Cristo giovanneo che dice “donna” ha ancora molto da insegnare alle nostre chiese e alle società che esse hanno contribuito a forgiare. Sento pressante, rispetto al nostro dire Dio con le parole, i gesti e le scelte, il monito di Gesù: “Voi siete obbedienti più alle tradizioni dei padri che al comando di Dio”. E spero che tra cent’anni si possa ammonire di non essere più obbedienti alla tradizione delle madri che al comando di Dio».

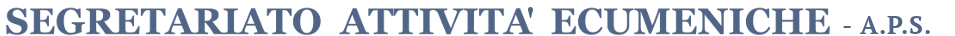
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE