Comunicato stampa n.7
 La sessione di formazione ecumenica del Sae di Assisi è giunta a esaminare lo snodo critico Chiese, ministeri, donne attraverso alcune voci appartenenti alle tre grandi arterie del cristianesimo. Athenagoras Fasiolo, vescovo di Terme, dell’Arcidiocesi ortodossa d’Italia del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, ha introdotto il suo intervento su due documenti: l’enciclica del Grande Concilio della Chiesa ortodossa a Creta del 2016 e il documento del Patriarcato ecumenico sulla dottrina sociale della Chiesa intitolato “Per la vita del mondo”. Ne ha evidenziato alcuni assiomi: l’essere la Chiesa una comunione divina-umana della Santa Trinità, assaggio delle cose ultime nella Divina Eucaristia e rivelazione delle cose future, continua Pentecoste, voce profetica inestinguibile nel mondo, “corpo di Cristo”. La Chiesa ortodossa, ribadisce il Concilio di Creta, «costituisce l’autentica continuazione della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica», così sente maggiore la sua responsabilità non solo per l’autentico modo di vivere della sua esperienza nel corpo ecclesiastico, ma anche per la testimonianza degna di fede della verità, in tutti gli uomini».
La sessione di formazione ecumenica del Sae di Assisi è giunta a esaminare lo snodo critico Chiese, ministeri, donne attraverso alcune voci appartenenti alle tre grandi arterie del cristianesimo. Athenagoras Fasiolo, vescovo di Terme, dell’Arcidiocesi ortodossa d’Italia del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, ha introdotto il suo intervento su due documenti: l’enciclica del Grande Concilio della Chiesa ortodossa a Creta del 2016 e il documento del Patriarcato ecumenico sulla dottrina sociale della Chiesa intitolato “Per la vita del mondo”. Ne ha evidenziato alcuni assiomi: l’essere la Chiesa una comunione divina-umana della Santa Trinità, assaggio delle cose ultime nella Divina Eucaristia e rivelazione delle cose future, continua Pentecoste, voce profetica inestinguibile nel mondo, “corpo di Cristo”. La Chiesa ortodossa, ribadisce il Concilio di Creta, «costituisce l’autentica continuazione della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica», così sente maggiore la sua responsabilità non solo per l’autentico modo di vivere della sua esperienza nel corpo ecclesiastico, ma anche per la testimonianza degna di fede della verità, in tutti gli uomini».
Athenagoras ha sottolineato il legame tra la Chiesa di Cristo che vive nel mondo ma non è del mondo, presenza e segno del Regno di Dio nella storia che annuncia nuovi cieli e terra nuova, e la divina Eucaristia che riunisce insieme i figli di Dio in un solo corpo senza distinzione di sesso, razza, età, stato sociale o altro. Questa stessa Chiesa non resta indifferente ai problemi dell’uomo in ogni epoca, partecipa alla sua angoscia e ai suoi problemi esistenziali. Il vescovo ha ricordato che l’annuncio del vangelo è la missione della chiesa e deve essere fatto con amore, umiltà e rispetto nei confronti dell’identità di ogni uomo e della specificità culturale di ogni popolo.
 Resta aperto il rapporto tra ministeri, carismi e il sacerdozio universale dei credenti. Nella teologia ortodossa Cristo come sommo sacerdote che ha sacrificato la propria vita ha trasmesso il sacerdozio ai dodici apostoli e perciò la sua origine è divina. Due sono i sacerdozi che, senza confusione né separazione, nella differenziazione dei carismi e dei ministeri, realizzano l’unico Cristo. Cristo solo è Sacerdote, tutti sono sacerdoti per partecipazione, alcuni sono vescovi e presbiteri. «Tra sacerdozio regale e sacerdozio dell’ordine non c’è frattura - ha precisato Fasiolo -. Nell’Ortodossia non esiste un egualitarismo antigerarchico o la frattura clericale del Corpo in due parti. Tutti partecipiamo a un unico sacerdozio ma in due modi. C’è una distinzione funzionale tra i due sacerdozi ma anche un’armonica collaborazione tra i due ordini, quali elementi sostanziali della Chiesa».
Resta aperto il rapporto tra ministeri, carismi e il sacerdozio universale dei credenti. Nella teologia ortodossa Cristo come sommo sacerdote che ha sacrificato la propria vita ha trasmesso il sacerdozio ai dodici apostoli e perciò la sua origine è divina. Due sono i sacerdozi che, senza confusione né separazione, nella differenziazione dei carismi e dei ministeri, realizzano l’unico Cristo. Cristo solo è Sacerdote, tutti sono sacerdoti per partecipazione, alcuni sono vescovi e presbiteri. «Tra sacerdozio regale e sacerdozio dell’ordine non c’è frattura - ha precisato Fasiolo -. Nell’Ortodossia non esiste un egualitarismo antigerarchico o la frattura clericale del Corpo in due parti. Tutti partecipiamo a un unico sacerdozio ma in due modi. C’è una distinzione funzionale tra i due sacerdozi ma anche un’armonica collaborazione tra i due ordini, quali elementi sostanziali della Chiesa».
Athenagoras ha rilevato che fa specie che nell’Ortodossia non ci sia qualcosa dedicato esclusivamente alla questione femminile ma non lo reputa negativo. «Entrambi siamo credenti e uniti in una sola vita in Cristo. La Chiesa ortodossa non percepisce l’uguaglianza come livellamento, la varietà in questo non si oppone all’unità. Ecco perché nell’Ortodossia non ci sono stati mai movimenti o rivoluzioni che correggessero le tendenze che l’unità aveva di volta in volta».
Nella visione ortodossa la donna simboleggia la chiesa stessa che accoglie il corpo dei credenti: «per questo – ha spiegato il vescovo - il suo ministero nella Chiesa è opera di amore e di carità verso il prossimo con la sua missione interiore ed esteriore. Il contributo simbolico delle donne alla vita ecclesiale è un’opera che abbraccia l’intero gregge e non è paragonabile a un ufficio ridotto alla consueta struttura gerarchica».
Nell’antichità le donne partecipavano alla vita liturgica come diaconesse e assumevano il lavoro sociale negli ospizi, negli ospedali e nelle confraternite. Una grande importanza ha avuto il monachesimo femminile. L’opera liturgica, catechetica, missionaria e sociale delle donne per l’Ortodossia è molto importante e viene ritenuta come sfondo dell’ufficio sacerdotale e in relazione alla spiritualità e alle inclinazioni personali femminili. Commenta Fasiolo: «La Chiesa ortodossa percepisce la liturgia non come potere ma come ministero, sacrificio e testimonianza. Riconosce alla donna un altro genere di ministeri importanti che è un’altra forma di sacrificio. Ecco perché le donne ortodosse che si ispirano a questa mentalità non condividono la protesta delle donne di altre confessioni sulla loro esclusione dal sacerdozio né le lotte per conquistare la fortezza del sacerdozio».
Fasiolo ha sottolineato l’importanza del lavoro moderno delle donne nella parrocchia, come catechiste, consigliere, pedagoghe, diaconesse, cantanti, autrici di opere filantropiche con responsabilità ed efficienza. Riconosce che negli ultimi anni l’affermazione del sacerdozio per le donne è stata espressa anche nell’Ortodossia anche se abbastanza timidamente. La posizione negativa della Chiesa ortodossa verso questa istanza non è motivata dal pregiudizio – ha spiegato – ma dal fatto che Gesù non scelse donne tra i dodici, benché fossero nella cerchia più ampia dei discepoli, e il suo esempio fu seguito dagli apostoli che non ordinarono donne. Un altro motivo è che per la teologia ortodossa il sacerdote è presenza fisica di Gesù e riveste un ruolo simbolico nei confronti della chiesa come sposo che rappresenta Cristo.
Oggi i cristiani, ha concluso, non devono considerare accettabili le situazioni di discriminazione ma seguire un percorso che attraverso la sensibilizzazione, l’educazione, il dialogo aiuti a cambiare i valori e impedisca la svalutazione delle persone. «Dobbiamo lavorare affinché le società cambino il loro centro, ponendo l’accento non sul potere ma sull’amore, sull’essere umano e sui suoi bisogni».
 «Per la riflessione sul tema delle donne e del ministero ordinato nella Chiesa cattolica bisogna fare riferimento al Concilio Vaticano II. La questione emerge perché due vescovi nella fase preparatoria chiedono la presenza di diaconesse e durante il Concilio altri due chiedono l’ordinazione o l’istituzione di donne diacono» ha esordito la teologa cattolica Serena Noceti. Ma il tema non entra nel dibattito conciliare. Contemporaneamente gruppi di donne sollecitano la questione e in particolare un gruppo di teologhe e giuriste pubblicano il saggio “Non siamo più disposte a tacere” e lo distribuiscono ai padri conciliari. Avviene anche un incontro ecumenico riservato dove partecipano alcune delle ventitré uditrici, delle diaconesse luterane e alcuni teologi rilevanti. Dopo il Vaticano II comincia la ricerca di tipo storico, biblico, liturgico e le donne iniziano a studiare teologia sistematica. Nell’arco di pochi anni il tema diventa avvertito e accompagna un fiorire di ministeri di fatto e corresponsabilità che coinvolge i laici e cambia il volto della chiesa.
«Per la riflessione sul tema delle donne e del ministero ordinato nella Chiesa cattolica bisogna fare riferimento al Concilio Vaticano II. La questione emerge perché due vescovi nella fase preparatoria chiedono la presenza di diaconesse e durante il Concilio altri due chiedono l’ordinazione o l’istituzione di donne diacono» ha esordito la teologa cattolica Serena Noceti. Ma il tema non entra nel dibattito conciliare. Contemporaneamente gruppi di donne sollecitano la questione e in particolare un gruppo di teologhe e giuriste pubblicano il saggio “Non siamo più disposte a tacere” e lo distribuiscono ai padri conciliari. Avviene anche un incontro ecumenico riservato dove partecipano alcune delle ventitré uditrici, delle diaconesse luterane e alcuni teologi rilevanti. Dopo il Vaticano II comincia la ricerca di tipo storico, biblico, liturgico e le donne iniziano a studiare teologia sistematica. Nell’arco di pochi anni il tema diventa avvertito e accompagna un fiorire di ministeri di fatto e corresponsabilità che coinvolge i laici e cambia il volto della chiesa.
Ha continuato la teologa: «Nel 1971 nel Sinodo dei vescovi sul sacerdozio ministeriale il tema viene affrontato e i vescovi canadesi chiedono di costituire una commissione che studi i testi biblici. La sintesi del lavoro dice che niente nel Nuovo Testamento impedisce l’ordinazione delle donne. La ricerca si sviluppa in questi sessant’anni in diverse ondate. Due documenti fondamentali sanciscono la posizione del magistero cattolico: il documento della Congregazione per la dottrina della fede Inter insigniores e la lettera apostolica di Giovanni Paolo II Ordinatio sacerdotalis». Il primo raccoglie le motivazioni intorno ad alcuni argomenti di base – la scelta di Gesù, la tradizione ininterrotta –, argomenti su questioni antropologiche, il richiamo all’antropologia di Tommaso e l’idea del ministero ordinato in chiave cristologica. Ordinatio sacerdotalis nel 1994 dichiara che la Chiesa cattolica non ha facoltà di ordinare donne ai gradi sacerdotali e che questa dottrina è irreformabile perché deve essere ritenuta in maniera definitiva. «Le motivazioni – ha spiegato la teologa - sono la scelta di Gesù e la tradizione ininterrotta. Francesco riprende in Evangelii Gaudium e in Querida Amazonia l’argomento dell’agire in persona Christi, ma questo testo non impedisce di dibattere sull’ordinazione diaconale. Molti e molte ritengono che i gradi sacerdotali dopo il Vaticano II sono presbiterato ed episcopato, mentre il diaconato è un grado ministeriale non sacerdotale che peraltro ha attestazioni fino al VII secolo. Il tema riemerge nel contesto del Sinodo ed è interessante vedere che le sintesi delle diocesi a livello mondiale presentano il tema, e il documento di lavoro per la tappa continentale, “Allarga lo spazio della tua tenda”, dedica uno spazio alla questione dell’ordinazione diaconale e alcuni in maniera più dibattuta richiamano anche l’ordinazione presbiterale». Precisa Noceti: «All’interno di questo è importante distinguere il livello di richiesta sul ministero e il livello di richiesta di autorità. Sono livelli collegati ma non vanno confusi. Nelle sette sintesi continentali ci sono reazioni diverse: in America Latina, Europa, parte del nord America e in Australia viene richiesta soprattutto l’ordinazione diaconale; in Africa e in Asia la richiesta non emerge con la stessa chiarezza. Il tema va affrontato riconoscendo che ci sono modalità diverse di esercitare l’autorità a seconda dei contesti e queste sono legate anche alle questioni di genere. In Europa c’è differenza tra i paesi dell’ovest e dell’est».
Il tema è avvertito come uno dei temi importanti nell’Instrumentum laboris sotto i due livelli, rileva Noceti. «Molto ampia è la trattazione su donne e ruoli di autorità - i cambiamenti che le diocesi devono fare per riconoscere l’apporto delle donne che già esiste ma deve essere incrementato sulla base del battesimo - e sulla richiesta di dibattere l’ordinazione diaconale. Però questa è posta all’interno della parte legata al riconoscimento della soggettualità battesimale delle donne e non dove si parla della riforma del ministero ordinato. Questo costituisce una precomprensione che non è presente in altri documenti. Papa Francesco ha operato molto per i riconoscimenti di ruoli di autorità nella Curia romana anche se solo parzialmente viene seguito dalle diocesi nella maniera corrispondente. Ha fatto molto per la questione dei ministeri istituiti: avremo ruoli nella chiesa locale, riconosciuti per tutta la vita, un cambiamento che rompe la bipolarità clero-laici e apre alla pluriministerialità: ministeri di fatto, ministeri istituiti, ministeri ordinati. Questo vuol dire che tutti siamo corresponsabili in forme diversificate».
Verso la conclusione la teologa ha posto due questioni. La prima è: come si pensa una teologia del ministero a livello ecumenico ma nella Chiesa cattolica? Sintetizzando, la si pensa sulla base della Scrittura, nella Tradizione e nel sensum fidei. La seconda questione è: quale teologia del ministero teniamo presente? Noceti rileva che «il Vaticano II ha sancito una cesura che riguarda la comprensione del ministero ordinato la cui funzione è nel servire la fede apostolica e il noi ecclesiale. Il Vaticano II abbandona lo schema del “potere sacro” e del “potere di giurisdizione” e sceglie di ritornare alla fonte sacramentale, alla forma tripartita - vescovo presbiteri diaconi -, a una visione collegiale, e sceglie i tre munera Christi: munus docendi, munus santificandi, munus regendi ac pascendi. Il tutto parte dal riconoscimento della sacramentalità dell’episcopato e la restituzione del diaconato come un grado autonomo e permanente con una funzione liturgica e con funzioni pastorali. Nel caso del diaconato abbiamo un ministero ordinato non sacerdotale come dice Lumen Gentium 29. Da questi elementi ho tratto un’indicazione. Per un dibattito sul ministro ordinato alle donne dobbiamo partire da questa teologia conciliare del ministero ordinato. Non la teologia della rappresentanza cristologica, sacerdotale, ontologica, dell’agire in persona del Cristo capo che era propria del Concilio di Trento e che in alcune forme è tornata negli anni ’80 e ’90. Questo cambia proprio la prospettiva». Perciò la teologa afferma che «il diaconato è possibile ed è anche necessario non solo per le donne ma per la Chiesa. Perché è un ministero ordinato non sacerdotale, ed è una modalità di vivere il ministero ordinato non sacrale e questo costringe tutti i ministri ordinati a ripensarsi. Non è una concessione di grado inferiore, ma una correlazione ministeriale diversa. È importante ricordare che il diaconato non è un ministero istituito. Ad Gentes 16 riconosce uomini che già esercitano funzioni diaconali e che giova alla chiesa che si impongano le mani su di loro. Io penso che questo andrebbe pensato anche per le donne che già esercitano ministeri diaconali enumerati dal decreto. Visto che nella Tradizione non c’è niente contro, anzi abbiamo più di un centinaio di attestazioni di donne diacono nell’antichità, e visto che abbiamo riti che ritengo di ordinazioni diaconali, giova alla chiesa questo passaggio. Non esiste riforma missionaria e sinodale della Chiesa, come chiede papa Francesco, senza una riforma dei ministeri ordinati e il riconoscimento dei ministeri istituiti, passo che già Francesco ci ha fatto fare». Al termine del suo intervento la teologa ha osservato: «Nel presente il passato, che è sempre istruttivo, non può pretendere di essere necessariamente normativo. Noi non siamo governati dal passato, ma dall’adattamento della tradizione ai bisogni dell’oggi. La storia ci può solo aiutare a decidere quali siano le cose essenziali di una tradizione e i parametri dell’adattamento».
 Per Davide Romano, direttore dell’Istituto avventista Villa Aurora di Firenze, «urge una forte rivisitazione della teologia dei ministeri. La ministerialità va mantenuta nel segno della diaconia che nasce da una investitura carismatica, funzionale alla edificazione costante della comunità. Ma il carisma è appunto un dono che viene fatto ai battezzati e alle battezzate in Cristo. I carismi dello Spirito hanno una duplice funzione: coinvolgere il credente nell’opera che Dio compie nella storia, anche nella sua storia personale, biografica; edificare e consolare la comunità ecclesiale». Il teologo ritiene che nella storia della chiesa ci sia stata un’accentuazione sul ruolo dell’episcopo e la progressiva estenuazione della collegialità nella chiesa. Riconosce che oggi, in ambito cattolico, vi è una feconda e vivace discussione sulla sinodalità della chiesa. «Il protestantesimo, dove più dove meno, sente di aver comunque fatto proprio senza particolari riserve il modello sinodale di chiesa. Nelle chiese evangeliche, specie quelle riformate, il ruolo episcopale è esercitato da un organo collegiale: consiglio, concistoro, sinodo, assemblea. La sinodalità della chiesa non è però acquisita per sempre - è pur sempre un cammino fatto insieme, insieme sulla stessa via - e non è detto che funzioni sempre nella maniera virtuosa. Le chiese protestanti hanno senz’altro potuto fare esperienza di comunità più egualitarie, inclusive e accoglienti». Nel 1967 in Italia è stata consacrata la prima pastora valdese, dal 1979 con il Patto d’integrazione il pastorato è stato aperto anche alle donne metodiste; dagli anni ’80 sono state consacrate pastore le battiste e le luterane. La Chiesa avventista – ha osservato il pastore - non ha ancora risolto in modo convincente il tema della parità di genere nei cosiddetti ministeri ordinati. «Ne parliamo in maniera serrata dagli anni ‘60 anche noi, con la continua istituzione di commissioni di studio. Le donne hanno delle responsabilità, perché sovente per rispettare il sensus ecclesiae non hanno voluto assumere iniziative atte a sollevare il problema. Le diacone e le anziane hanno la loro ordinazione, ma non ancora le pastore, che posseggono la qualifica però non ancora la consacrazione attestata. Nella Bibbia non ci sono impedimenti all’ordinazione ministeriale delle donne, ma quando c’è da ratificare questo tema a livello mondiale nella nostra Conferenza generale, negli Stati Uniti, la maggioranza dei delegati che provengono dall’Africa non vogliono l’ordinazione delle donne».
Per Davide Romano, direttore dell’Istituto avventista Villa Aurora di Firenze, «urge una forte rivisitazione della teologia dei ministeri. La ministerialità va mantenuta nel segno della diaconia che nasce da una investitura carismatica, funzionale alla edificazione costante della comunità. Ma il carisma è appunto un dono che viene fatto ai battezzati e alle battezzate in Cristo. I carismi dello Spirito hanno una duplice funzione: coinvolgere il credente nell’opera che Dio compie nella storia, anche nella sua storia personale, biografica; edificare e consolare la comunità ecclesiale». Il teologo ritiene che nella storia della chiesa ci sia stata un’accentuazione sul ruolo dell’episcopo e la progressiva estenuazione della collegialità nella chiesa. Riconosce che oggi, in ambito cattolico, vi è una feconda e vivace discussione sulla sinodalità della chiesa. «Il protestantesimo, dove più dove meno, sente di aver comunque fatto proprio senza particolari riserve il modello sinodale di chiesa. Nelle chiese evangeliche, specie quelle riformate, il ruolo episcopale è esercitato da un organo collegiale: consiglio, concistoro, sinodo, assemblea. La sinodalità della chiesa non è però acquisita per sempre - è pur sempre un cammino fatto insieme, insieme sulla stessa via - e non è detto che funzioni sempre nella maniera virtuosa. Le chiese protestanti hanno senz’altro potuto fare esperienza di comunità più egualitarie, inclusive e accoglienti». Nel 1967 in Italia è stata consacrata la prima pastora valdese, dal 1979 con il Patto d’integrazione il pastorato è stato aperto anche alle donne metodiste; dagli anni ’80 sono state consacrate pastore le battiste e le luterane. La Chiesa avventista – ha osservato il pastore - non ha ancora risolto in modo convincente il tema della parità di genere nei cosiddetti ministeri ordinati. «Ne parliamo in maniera serrata dagli anni ‘60 anche noi, con la continua istituzione di commissioni di studio. Le donne hanno delle responsabilità, perché sovente per rispettare il sensus ecclesiae non hanno voluto assumere iniziative atte a sollevare il problema. Le diacone e le anziane hanno la loro ordinazione, ma non ancora le pastore, che posseggono la qualifica però non ancora la consacrazione attestata. Nella Bibbia non ci sono impedimenti all’ordinazione ministeriale delle donne, ma quando c’è da ratificare questo tema a livello mondiale nella nostra Conferenza generale, negli Stati Uniti, la maggioranza dei delegati che provengono dall’Africa non vogliono l’ordinazione delle donne».
Il teologo ha concluso proponendo sei tesi sulla Chiesa che potrà venire: 1) la Chiesa di Gesù, con una pluralità di forme, dovrà sempre più essere strutturalmente plurale nel rispetto dei generi e delle generazioni. La pluralità, cioè una vera e compiuta sinodalità, non potrà più essere solo un possibile modello organizzativo tra altri. 2) la Chiesa di Gesù potrà solo essere egualitaria, cioè ciascuno deve sentirsi ugualmente accolto alla mensa del Signore come discepolo e come discepola del Risorto. E ciascuno, ciascuna deve sentire come decisiva la propria presenza per la comunione e la riuscita della missione. 3) La Chiesa di Gesù può solo essere carismatica, cioè nutrita dai doni dello Spirito e dalla sua presenza. La ministerialità potrà essere vissuta solo nella consapevolezza della uguaglianza di status tra battezzati e battezzate. 4) la Chiesa di Gesù sarà libertaria e disciplinata dai comandamenti di Dio. La libertà non vorrà mai fraintendere la disciplina, e la disciplina non potrà contendere con la libertà evangelica. 5) La Chiesa di Gesù non si identificherà con un popolo, una nazione, un governo, perché ogni volta che lo ha fatto ha smarrito sé stessa. 6) la Chiesa di Gesù è molteplice ed ecumenica ed escatologica. Le molte voci e le diverse tradizioni sono non un accidente storico, ma un volere dello Spirito che unifica diversificando».

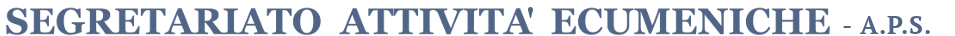
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE