
La Dichiarazione è un frutto del lavoro di preparazione e della realizzazione del convegno “Cosa ci ha lasciato Martin Lutero? Per una conclusione aperta del Quinto Centenario della Riforma” organizzato il 6 e 7 ottobre dall’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei e dalla Chiesa evangelica luterana in Italia. Il documento riconosce il valore ecumenico degli eventi comuni promossi in questo anno e sottolinea l’importanza della lettura congiunta delle Sacre Scritture come sorgente di unità tra cristiane e cristiani. «Rafforzare l’amicizia nella fraternità, ai piedi della croce di Cristo – conclude il testo - ci aiuterà a favorire una riconciliazione delle memorie in grado di sostenere cattolici e luterani nell’annuncio e nella testimonianza della Parola di Dio nella società contemporanea, per promuovere una riforma sempre più evangelica della vita quotidiana delle comunità locali».
Durante il convegno che ha partorito questa dichiarazione, il 6 ottobre 2017 siamo tornati nella cattedrale di Trento, divenuta nel XVI secolo simbolo di divisione, per vivere una celebrazione ecumenica all’insegna della riconciliazione e del ringraziamento per una rinnovata fraternità. C’eravamo un anno prima, il 17 novembre 2016, anche in quella occasione convocati dall’Ufficio ecumenismo e dialogo della Conferenza episcopale italiana per il convegno “Cattolici e protestanti a 500 anni dalla Riforma; uno sguardo comune sull’oggi e sul domani”: l’anno scorso cattolici e protestanti di diverse denominazioni, quest’anno cattolici e luterani. Entrambe i convegni sono stati organizzati in stretta collaborazione con i partners - nel 2016 la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, nel 2017 la Chiesa evangelica luterana in Italia - che sono intervenuti con i loro rappresentanti, vescovi e presidenti di chiese e Federazione.

Un centinaio di partecipanti, un clima amicale, il desiderio di esserci perché lo ritenevamo un appuntamento da non perdere. Ne hanno sottolineato l’importanza, prima di cominciare i lavori, i nostri ospiti, don Cristiano Bettega e il pastore Heiner Bludau. «La nostra scelta di essere qui è quella di avere scelto l’ecumenismo non come una questione di facciata o di convinzione personale, ma per una questione di logica coerenza con il vangelo. La responsabilità è anche questa: continuare a dialogare tra noi e con tutti coloro che incontriamo, portare avanti uno spirito che non è di un gruppo sparuto ma lo spirito del vangelo e delle nostre chiese» ha esordito il direttore dell’Unedi. Presenza mite e franca, interlocutore attento dei delegati diocesani all’ecumenismo e di chi si dedica a questa realtà, nello stile sinodale del Vescovo di Roma, don Bettega ha voluto che si creasse una Consulta nazionale per essere affiancato, anche da laici, nell’ascolto della voce dei territori e nell’elaborazione di orientamenti e programmi.
Per il decano della Celi, il convegno «è stato il culmine di quest’anno anche perché l’eredità di Lutero non è qualcosa della Chiesa luterana o contro la Chiesa cattolica ma un tesoro che dobbiamo scoprire insieme, e questo succederà solo se ci avviciniamo tra noi». «Un giubileo che ha aiutato a comprendere le diverse idee e a sviluppare benevolenza verso le altre tradizioni»: così il vescovo Karl-Hinrich Manzke, responsabile della Federazione delle Chiese luterane in Germania per le relazioni con la Chiesa cattolica, ha definito l’avvenimento che ha segnato il 2017, in Europa in particolare. «Questo convegno – ha continuato – è stato un contributo alla testimonianza comune della fede cristiana nel mondo che è la sfida di ogni cristiano. In una frase, cristiani uniti per un mondo in frantumi».
Nell’accogliente Centro Mariapoli sono state condivise esperienze e si è camminato sulla via dell’accoglienza e dell’amicizia; sono stati analizzati gli aspetti determinanti della teologia di Lutero (Angelo Maffeis; Karl-Hinrich Manzke) e si è parlato di “guarigione delle memorie” (Brunetto Salvarani; Heiner Bludau); si è pregato insieme e si è lavorato in gruppi di studio sui cinque imperativi ecumenici del documento “Dal conflitto alla comunione”.

Come si fa la “guarigione delle memorie”? Per Brunetto Salvarani occorre ammettere le proprie colpe e, come dice il documento del 2013, raccontare la storia in maniera diversa: condivisa. E poi imparare a guardare il dolore dell’altro, curare il rapporto con gli ebrei riconoscendo la perennità dell’elezione di Israele, evitare nelle relazioni intracristiane il rischio della ripetizione di una teologia sostituzionista. In un anno caratterizzato da incontri che hanno segnato una svolta, come la commemorazione luterano-cattolica di Lund del 31 ottobre 2016, a cui ha partecipato Francesco, è importante che «i gesti ai vertici diventino storie vissute alla base nelle nostre parrocchie e comunità, esperienze che precedono il dialogo teologico» e che in questo tempo senza più sicurezze la chiesa non tema la fragilità, ma la sappia «abitare capire e amare, con le potenzialità e le risorse nuove che comporta. Solo chi riconosce la fragilità può costruire relazioni fraterne e solidali». Nella preghiera ecumenica del 2017 nella Cattedrale di Trento un gesto inedito ha voluto suggellare l’impegno a praticare la diaconia nel mondo: la lavanda dei piedi tra il vescovo cattolico e il vescovo luterano. Alla quale può essere attribuito un significato ulteriore ricordando che nel racconto della Cena di Giovanni Gesù lava i piedi dei discepoli: la tensione verso quell’Eucaristia che ancora oggi le chiese non condividono.
I cinque gruppi di studio sui cinque “imperativi ecumenici” - formati da persone cattoliche e luterane residenti tra Bolzano e la Sicilia, laiche e laici, delegati diocesani per l’ecumenismo e il dialogo, insegnanti di religione cattolica, membri di movimenti ecclesiali, pastore e pastori - si sono rivelati laboratori di condivisione di buone prassi e di elaborazione di idee che mostrano e possono favorire una presa di coscienza sul fatto che oggi non si può essere cristiane e cristiani senza essere ecumeniche ed ecumenici, come sostiene da tempo Brunetto Salvarani.

Al di là di iniziative consolidate come la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani o del positivo lavoro dei Consigli delle chiese cristiane là dove sono presenti, è stata sottolineata l’importanza degli incontri feriali e informali tra persone, tra famiglie e comunità che favoriscono la conoscenza, la pratica concreta dell’ascolto e la condivisione. Lo stesso Heiner Bludau sottolineava nel suo intervento l’importanza della riconciliazione nella concretezza della vita, e invitava a «presentare nel dialogo con gli altri ciò che ci tocca personalmente», a «invitarci reciprocamente a partecipare alle nostre messe e culti» come possibilità per «imparare la lingua liturgica dell’altra chiesa» e così «capire l’altro nel suo mondo», condizione fondamentale per la riconciliazione. Atti e gesti verso la costruzione di una prossimità che il vescovo di Trento Lauro Tisi ha visto in atto nella «dolce benedizione degli sguardi» che in questo anno cattolici e luterani hanno ricevuto in dono.
Laura Caffagnini
foto di Laura Caffagnini

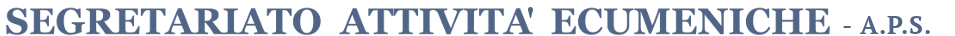
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE