La giornata di giovedì 26 luglio 2012, si è aperta con la preghiera e meditazione biblica (2 Cor 9, 6-10), tenuta da Padre Gheorghe Vasilescu (Arciprete ortodosso romeno – Torino) ed è continuata con la tavola rotonda sul il tema “Interculturalità e pace”, tenuta da Brunetto Salvarani (Saggista, direttore Cem-Mondialità - Carpi), Bruno Segre, Direttore di Keshet – Milano) e Ouejdane Mejri (Presidente Associazionene Pontes, Tunisini in Italia).
Presentato dalla Presidente Marianita Montresor, in un clima di profondo ascolto meditativo, Padre Gheorghe ha indicato i tanti aspetti del donare da parte dei cristiani, a partire dalle parole dell’Apostolo e dalla colletta da lui promossa per i bisognosi di Gerusalemme, “lezione ideale e classica della solidarietà, (che non cambia il mondo ma lo migliora), della comunione generosa dei beni di questo mondo, per avere l’abbondanza della mietitura non solo ora ma nel sempre dell’escathon”. Poiché il dono “arricchisce il donatore”, “la generosità è estremamente produttiva”. “Date e visarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante” (Lc 6,38) avverte Gesù.
Come dare? Con generosità.
Quanto dare? Il quanto è da stabilirsi nel cuore, con una decisione privata, precisa e calcolata, soppesando accuratamente tutti i fattori in gioco. Si deve donare ‘in busta chiusa’ ed anonima.
La prima scuola del fare il bene è la famiglia, “piccola Chiesa” dove, “in spirito di imitazione, proprio dei bambini, imparano la generosità, la misericordia”.
A chi dare? “Dove c’è bisogno, a chiunque si trovi nel bisogno; felice è chi può dire “Signore fa con me come io ho fatto con il mio prossimo” (S. Gregorio di Nissa).
INTERCULTURALITA’ e PACE
Dio, le chiese, le religioni si stanno globalizzando, ha esordito Salvarani, e “stanno cambiando indirizzo”. Questo riguardala Chiesa cattolica, ma anche l’Islàm, il Buddhismo, le tradizioni orientali in Occidente e le Chiese e tradizioni occidentali in Oriente. Siamo in uno stato di “crisi permanente”, tutto cambia così rapidamente da impedire di “fotografare la realtà”. Ci troviamo a “cavalcare la transizione continua nel passaggio in cui siamo chiamati a so-stare”.
“Lo spaesamento è un dato di fatto”: dobbiamo “stare nelle contraddizioni, nelle fatiche, nei problemi adottando uno sguardo glo-cale” al mondo, a partire dal proprio ambiente.
Tre sono le lezioni acquisite nel tempo: “quando si attraversa il confine di un altro contesto, si apprende qualcosa sull’altro, ma soprattutto su se stessi”, e si constata come “c’è qualcosa dell’altro che non potremo mai sapere”, eco di un detto di Qoelet fulminante: “Ciò che manca non lo si può contare” (Qohelet 1, 15b).
L’interculturalità è assolutamente necessaria, un passaggio inevitabile. L’intercultura è “la presa di coscienza che nessun uomo è un’isola (Thomas Merton) e nessun gruppo umano può farcela da solo. Ogni cultura deve essere apprezzata e valorizzata. Noi siamo un insieme di culture (Amartja Sen, in Identità e violenza)”. Usiamo ancora troppo la parola integrazione, che “va abolita”. E’ “necessaria un’interazione”, fatta di accoglienza, di sguardo, di “conoscenza reciproca e continua”.
Come dice Raimon Panikkar, sull’orizzonte si pone “una mutua fecondazione delle culture”, un “dialogo dialogale”, che è “un atto religioso per eccellenza” con alla base la fiducia nell’altro, cui avvicinarsi “con passo leggero”. Ricordando che spesso il silenzio è più efficace delle parole, è ricerca dell’armonia e della pace, “con cuore puro e mente aperta”.
Quindi, riconoscendo che siamo nani sulle spalle di giganti, Salvarani ha condiviso lo stupore e la gioia di un incontro ad Assisi con “due grandi anime”, due icone del tema dell’interculturalità e della pace: Bruno Hussar e Raimon Panikkar.
Alla domanda: quale dovrebbe essere il tema del prossimo concilio, Hussar rispose immediatamente il Gerosolimitano II, che dovrà prendere atto per la prima volta di che cosa significhi l’ebraicità di Gesù, ridisegnando ecclesiologia e missiologia. Per Panikkar invece un Vaticano III dovrà mettere a fuoco il fatto che Gesù è un Gesù planetario, delle tradizioni latino-americane, africane, asiatiche, dell’Oriente e dell’Occidente, perché Egli non è bianco, non è europeo e non è eurocentrico.
Come vivere “noi e Dio oggi in un mondo in fuga”? Salvarani ha risposto rielaborando i 9 Sutra sulla pace (mutuati dalla tradizione buddhista) di Panikkar, che aveva vedute larghissime e lungimiranti.
- La pace è partecipazione all’armonia del ritmo dell’Essere.
- È difficile vivere senza pace esterna; impossibile senza quella interna.
- La pace non la si conquista per se stessi, né la si impone agli altri. E’ dono dello Spirito.
- La vittoria ottenuta con la sconfitta violenta del nemico non conduce mai alla pace.
- Il disarmo militare richiede un disarmo culturale.
- Nessuna cultura, religione o tradizione può risolvere isolatamente i problemi del nostro mondo.
- La pace appartiene principalmente all’ordine del mythos, non del logos.
- La religione, via verso la pace.
- Perdono, riconciliazione, dialogo: solo essi conducono alla pace.
Allorché, attorno al 1990, la dissoluzione dell’Unione Sovietica pose termine a decenni di guerra fredda - ha detto Segre -, vi fu chi fantasticò sulla ‘fine della storia’ e sulla nascita di un nuovo ordine mondiale. “In realtà, ci stiamo ora rendendo conto che il pianeta Terra - un pianeta molto densamente popolato e sempre più piccolo - è dominato da un disordine globale rischiosissimo, nelle cui pieghe si celano e si scaricano tensioni economiche, politiche e socio-culturali d’ogni natura, che nessuno sembra in grado di governare o anche soltanto di censire”.
Sullo sfondo di tali tensioni, “le culture che oggi, nel concreto dello spazio mediterraneo si incontrano, si confrontano o si scontrano, sono quelle di Paesi come il nostro, appartenenti al Nord opulento e tecnologico del mondo che, costituendo poco più di un decimo dell’umanità, consuma oltre l’80 per cento delle risorse del pianeta, e le culture di Paesi in cui vivono, o da cui transitano, le avanguardie migranti delle moltitudini del Sud del mondo, alle quali non rimangono se non le briciole, la disperazione e la rabbia”.
L’obiettivo di un sano progetto di interculturalità “è quello di ‘creare’ nuovi cittadini, di far crescere nuove risorse umane, di arricchire la cittadinanza grazie ad apporti provenienti da altre radici, da altri legami, da nuove energie”. Il dibattito interculturale globale è in corso, ma è “viziato dalla propaganda xenofoba e dall’impropria dislocazione sul piano religioso di molte questioni che sono più propriamente di natura economico-sociale”.
Per il futuro del pianeta “è essenziale il dialogo, giacché soltanto esso ci permette di incontrare, trovare quello che ci unisce, come i problemi della nostra epoca che non sono appannaggio di alcun gruppo sociale o di alcuna specifica comunità. Ed è proprio qui, su questo terreno, che una precipua missione formativa, preziosissima, può essere nuovamente assunta - ma questa volta in un orizzonte globale - dalle tre grandi tradizioni religiose ‘mediterranee’ del ceppo abramitico: ebraismo, cristianesimo e islam, che per molti secoli si sono incontrate e hanno messo a confronto, spesso in termini aspramente competitivi, i propri sistemi di valori. Depositarie di saperi teologici elaborati in tempi ormai remotissimi, esse sono oggi chiamate, ciascuna per suo conto, a ricontestualizzare i propri valori per metterli in condizione di misurarsi efficacemente con le più devastanti conseguenze della globalizzazione in atto”.
“Penso - ha proseguito Segre - , che le urgenze che stiamo attualmente vivendo impongano alle nostre tre grandi tradizioni un compito di vitale importanza, da affrontare in comune e, possibilmente, da condividere con tutte le altre diverse espressioni di spiritualità. Si tratta di diffondere il più possibile la consapevolezza che sul pianeta Terra siamo ormai tutti interdipendenti”. Tocca alle grandi correnti della vita spirituale “mettere l’umanità intera di fronte alle comuni responsabilità verso la salvaguardia dell’ambiente globale, oggi messo più che mai a repentaglio dagli effetti della “distruzione creativa che chiamiamo ‘progresso’” (l’espressione “distruzione creativa” è di Zygmunt Bauman). E poiché con tutta evidenza le economie delle varie regioni del mondo vanno rapidamente integrandosi in un’economia globale, sia pure in modo molto doloroso, imperfetto e con costi sociali gravosissimi, è di vitale importanza che le più solide espressioni di spiritualità ci aiutino ad assumere coscienza che il benessere di ciascuno di noi non soltanto è collegato, ma dipende dal benessere di tutti gli altri uomini, esattamente come il benessere di ciascuno di loro è collegato e dipende dal nostro”.
Il relatore ha concluso con una citazione di straordinaria valenza universalistica: “Voi amerete lo straniero perché siete stati stranieri nella terra d’Egitto” (Deuteronomio, 10, 19). Ed ha chiosato: “Vorrei che dalla Bibbia ogni creatura umana, a incominciare da me, traesse e facesse sua questa esortazione e se la imprimesse con vigorosa semplicità nella mente e nel cuore”.
“Pace tra le culture alla prova delle primavere arabe” l’angolo di visuale illustrato da Ouejdane Mejri. “L'intercultura è una pratica corrente nel mondo contemporaneo caratterizzato da flussi rapidi e massicci di informazioni, beni e persone, in cui diventa sempre più difficile parlare di confini nel senso tradizionale del termine”, ha esordito Mejri. Il rapporto tra cultura e luogo “trasformandosi diventa meno forte, e l’Uomo sperimenta sempre più frequentemente il contatto con oggetti e idee di cui non intuisce sempre la provenienza. In questo contesto, il dialogo tra le diverse culture, le intersezioni e le contaminazioni sono dati di fatto e diventano condizioni di esistenza delle singole culture. Infatti, secondo l’antropologo Fredrik Barth ([1]^), l’identità di un gruppo non si definisce a partire del nucleo centrale ma alla frontiera con gli altri gruppi, e sono quindi i confini ad agire nel processo di attribuzione dell’identità, non il presunto “contenuto” culturale. Persino la conoscenza che una cultura ha di se stessa deriva da questo confronto dialettico con l'alterità”.
È storicamente provato come “alla base delle distinzioni più generali che le società sono capaci di instaurare (per esempio quella tra “noi” e “loro”) vi sia una continua opera di “costruzione di confini”. Infatti, per i componenti di un gruppo etnico o religioso, affermare la propria identità equivale a definire un principio di distinzione nei confronti di “altri”. Il rischio che ne consegue però è quello di sviluppare una visione rigida della realtà che ci rende schiavi degli stereotipi e dei pregiudizi senza riuscire a liberarcene. Dividendo continuamente il mondo in “noi” e “loro” e immaginando questo “loro” in maniera omogenea, senza immaginare che ci possano essere tante differenze interne in questo loro, quante ve ne sono nel nostro noi”.
La situazione pluralista in cui si trova attualmente l’umanità “rappresenta ‘il vero interrogativo pratico della coesistenza umana sulla terra’ ([2]^) che in generale, è dato dal riconoscimento simultaneo di due condizioni: 1) che è impossibile evitare l’interferenza reciproca, pur nella evidente incompatibilità di diversi punti di vista; 2) che questa incompatibilità genera sofferenza ([3]^). Le soluzioni ricorrenti proposte dalle politiche ma anche dal mondo accademico sviluppano due posizioni che contrappongono il monoculturalismo etnocentrico al relativismo culturale. Se nella prima soluzione si tenta di cancellare la differenza culturale nell’altra si cerca di accettare una molteplicità caotica riducendo l’incomprensibilità e l’incomunicabilità. La sofferenza di cui parla Panikkar non è altro che quel rischio chela Pace potrebbe incorrere in questi spazi in cui le culture convivono, ma in cui affrontano anche conflitti e scontri”.
Dagli inizi del 2011, “una gran parte del mondo islamico sta vivendo un mutamento epocale nella sua configurazione sociale e politica. Le dittature che hanno mantenuto per decenni questi paesi sotto il loro feroce controllo stanno una ad una cadendo portando da un lato l’accesso alla libertà a milioni di cittadini arabi e musulmani e dall’altra l’aumento di un sentimento di paura e di insicurezza nelle controparti occidentali. La paura principale è quella di una incompatibilità tra l’islam e la democrazia che potrebbe portare a conflitti irrisolvibili tra il mondo Occidentale e quello arabo”.
La domanda che interpella con forza è: “Che tipo di pace si potrebbe costruire in un mondo in cui gli spazi si intrecciano e in cui sussiste una vera e propria “promiscuità” culturale?”. Per poter immaginare oggi, in Europa, delle vie che possano tenere conto sia dell’esigenza di unità sia di quella di diversità e per affrontare la tematica della pace e dell’intercultura credo che sia essenziale porre la cosiddetta “primavera araba” al centro dell’attenzione. Questi mutamenti geo-politici nei paesi arabi sono determinanti per definire le dinamiche sociali, culturali e psicologiche non solo delle popolazioni in loco, ma anche di quei milioni di musulmani che oggi risiedono in Europa”.
È seguito un vivace dibattito.
[1] F. Barth (a cura di), Ethnic Groups and Boundaries, Oslo University Press,Oslo, 1969.
[2] R. Panikkar, Pace e interculturalità. Una riflessione filosofica, Jaca Book, Milano 2002
[3] Ibidem

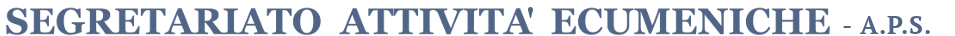
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE