Giustizia, ambiente, stili di vita – Riflessioni di Gruppo
Ci siamo occupati in particolare di crisi agricola e dei suoi legami con i cambiamenti climatici e la speculazione finanziaria, ma soprattutto di come consumi individuali e scelte produttive influiscono sui mercati. Perché il cibo è di tutti e dovrebbe essere per tutti. Ci riguarda quindi sul piano individuale e su quello dell'organizzazione della società, quindi della giustizia (non a caso il diritto a una alimentazione adeguata fa parte della Dichiarazione sui diritti umani).
Inoltre il rapporto che abbiamo con il cibo è rivelatore dei valori con cui stiamo al mondo.
La crisi agricola e la conseguente crisi alimentare è uno degli allarmi ricorrenti: oggi le curve del consumo e quelle della produzione (dei cereali per esempio) sono vicinissime, praticamente sovrapposte: produciamo ogni anno quanto consumiamo; bastano piccoli cambiamenti per mettere a rischio questo equilibrio; ogni variazione climatica o catastrofe naturale (siccità, alluvioni...) mette a rischio la possibilità di sfamarsi di aree vaste del pianete; la destinazione di crescenti superfici agricole a coltivazioni destinante non all'alimentazione (né umana né animale) ma a biocarburanti o bioplastiche (materBi) è una novità degli ultimi anni che contribuisce a cambiare i mercati e quindi le vite di tutti noi e in particolare dei più poveri; sugli squilibri del mercato si inserisce inoltre la speculazione finanziaria che enfatizza le ansie e che, di fronte al tema della scarsità, contribuisce alla lievitazione dei prezzi internazionali.
Ma non si tratta solo delle produzioni (e delle scorte alimentari che nel mondo non si riescono a ricostituire); si calcola infatti che un terzo circa del cibo che produciamo (almeno nel mondo occidentale) finisce per essere sprecato.
Il tema della giustizia qui si confronta quindi sempre più con il tema dello spreco, di chi si sente "padrone" di ciò di cui dispone o di ciò che compera.
In questo senso ci siamo raccontati i diversi significati che il "digiuno" ha nella tradizione e nelle prassi delle diverse confessioni cristiane e, in parte, nell'islam. In particolare ci ha colpito la tradizione del digiuno ortodosso (l'astinenza da tutti i cibi di derivazione animale in quattro grandi periodi dell'anno) che rimanda direttamente all'armonia dell'uomo nel giardino dell'Eden (Genesi 1,29-30) e alla libertà (libertà da ogni dipendenza, anche dalla dipendenza dal cibo).
Il metodo che abbiamo utilizzato ci sembra quello ecumenico: abbiamo provato ad ascoltare l'altro (anche quando l'altro è portatore, per esempio in tema di stili di vita, di un'esperienza scomoda o che percepiamo come "antipatica": il caso dei veganesimo); abbiamo cercato un linguaggio comune (le parole che usiamo non indicano lo stesso contenuto: ortodossi e cattolici e musulmani indicano, con la parola "digiuno" tre pratiche diverse); abbiamo ascoltato le esperienze e i sentimenti di cui siamo portatori sui temi proposti; su questi stessi temi abbiamo tentato alcuni approfondimenti rispetto al "senso comune" (per esempio su siccità-crisi agricola-aumento dei prezzi-rischio carestia).
Tra i punti sfiorati, ma che ci sembra possa rappresentare un tema di confronto tra le Chiese e nel dialogo interreligioso: il gioco d'azzardo, non soltanto consentito ma, in questi ultimi anni, promosso dallo Stato. Si tratta di una dipendenza nuova (nelle dimensioni) e in espansione. Ci sono alcune campagne e alcune prese di posizione contro il gioco d'azzardo che sta diventando uno "stile di vita". Come Chiese cristiane ci può essere una riflessione comune?
E su tutto: la necessità di un'informazione corretta e di realizzare reti di confronto e di scambio anche per condividere esperienze.
Infine, attraverso l'esperienza di "BIlanci di giustizia", abbiamo misurato l'impatto sociale di comportamenti individuali e familiari che, superando la dimensione moralistica, giungono a consentire la condivisione di processi di cambiamento possibili e incisivi già da ora.

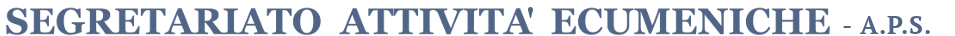
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE