2 agosto 2012
Un dialogo ecumenico sull’etica sociale
Una seconda sessione sull’etica, ma con una prospettiva diversa - e non penso alla differenza del paesaggio tra le colline toscane e le Prealpi venete, in questa terra che ci ha accolto con un affetto e una generosità che hanno trovato espressione forte nell’intervento di mons. Gianfranco Agostino Gardin e nell’omelia di mons. Beniamo Pizziol. Neppure mi riferisco alla maggior ricchezza di linguaggi – dal cinema ed al teatro al video utilizzato nell’intervento di Marco Campedelli fino alla “meditazione biblica multimediale” del pastore Daniele Pispisa. Nemmeno mi riferisco alla varietà di volti nuovi – il SAE sembra come uno scriba che sa trarre cose nuove e cose antiche dal tesoro dell’ecumene - che hanno arricchito il nostro incontro; e tra di essi merita segnalare le numerose donne, da Ouejdane Mejri a Ilenya Goss, operaia presa all’ultimissima ora per sostituire chi era stato costretto ad assentarsi.
La differenza forte è soprattutto quella tra l’etica fondamentale e l’etica applicata, tra un nocciolo fondamentale di esperienza morale vissuta personalmente e il suo articolarsi nelle aree e negli ambiti della vita. Quest’anno non si è trattato cioè tanto di esplorare alcune parole fondamentali, quanto di metterle alla prova in riferimento a situazioni specifiche e concrete aree problematiche - ed in particolare in riferimento a quell’etica sociale che da il sottotitolo alla sessione, a quell’istanza di giustizia cui chiama invece con forza il titolo. Un tema del tempo: tanti amici – che magari non sono stati poi presenti a Paderno e magari neppure particolarmente attenti al dialogo ecumenico – si sono complimentati per la scelta di un tema così attuale e per la sua articolazione. Un tema attuale, che - d’altra parte - non può esimersi dalla memoria (ce lo ha ricordato Amos Luzzatto – memoria della storia di un popolo, memoria del dolore). Noi lo abbiamo affrontato nella memoria del Concilio, a cinquant’anni dalla sua apertura, tenendo presente in particolarela Costituzione Conciliare “Gaudium et Spes” (relazione Giovanni Cereti), ma anche la riflessione sociale ecumenica del Consiglio Ecumenico delle Chiese e non solo (relazione Luca Maria Negro).
Etica sociale, dunque, e del resto è proprio in tale ambito che la riflessione morale è balzata in questi ultimi anni al centro del dibattito pubblico, andando ben aldilà degli spazi confessionali. È in tale direzione che guardano, ad esempio, testi come La questione morale di Roberta De Monticelli[1] o l’Elogio del moralismo di un laico come Stefano Rodotà, che vi si definisce “un vecchio, incallito, mai pentito moralista”[2]. È lui (e non qualche vecchio teologo cattolico) che sottolinea – con qualche tensione rispetto alla relazione di Debora Spini - come non sia più possibile ormai rivendicare ingenuamente uno slogan come l’autonomia dello spazio politico, nel momento in cui esso ha completamente smarrito le proprie forme di autoregolamentazione. Ed è proprio quando accadono fenomeni del genere, quando cioè vengono meno realtà e comportamenti che precedentemente potevano essere dati per scontati, che si fa più forte l’esigenza di una riflessione etica, per trovarne di nuovi, per rafforzare fondamenti e motivazioni.
- 1. Una preoccupata esigenza di giustizia
A monte della riflessione che abbiamo vissuto in questi giorni c’è indubbiamente una preoccupata esigenza di giustizia. Un’esigenza forte, che si esprime in primo luogo in una dimensione di rifiuto, quale è espresso dall’indignazione (potente emozione morale) dinanzi all’ingiustizia: il rifiuto di ciò che umilia, depotenzia l’humanum – quello in noi e quello nell’altro. Essa, però, rimanda anche in positivo all’istanza di ritrovare una forma di vita sociale in cui ad ognuno sia effettivamente possibile fruire del proprio fondamentale diritto a vivere da essere umano. Un diritto che a sua volta si articola nell’esigenza di essere rispettato nella propria umanità - e quindi non umiliato (lo sottolinea Avishai Margalit[3]) - in quella di poter sviluppare quelle capacità (capabilities nell’accezione di Amartya Sen[4] e Martha Nussbaum[5]) e che permettono all’esistenza delle persone di svilupparsi in forme pienamente umane – di fiorire – consentendo di fare ragionevoli piani di vita. Si tratta di una domanda globale, che si esprime a partire da una forma economica caratterizzata da elementi di ingiustizia strutturale a livello planetario[6] (lo segnalava il gruppo 5 in relazione al tema del cibo, bene essenziale per la vita); di una domanda che tocca profondamente le reazioni di genere (lo sottolineava il gruppo 4 con il richiamo ai diritti delle donne, come percorso di crescita comune che taglia trasversalmente le culture). Una domanda che può trovare risposta solo nella vita associata, nello spazio di una civitas intesa in senso ampio (si veda l’intervento di Paolo Ricca); non a caso per Edgard .Morin e Stéfane Hessel – in un piccolo testo scritto a due mani da questi grandi vecchi della cultura europea - il nostro primo dovere è quello di “essere cittadini che partecipano al destino planetario”[7].
Tale domanda, però, è anche intrecciata oggi con una preoccupata e drammatica percezione della fragilità della civitas e delle sue istituzioni di fronte al drammatico convergere di una serie di minacciose dinamiche:
- Un’economia che ha assunto il volto di sistema autoreferenziale, in cui è difficile cogliere effettive relazioni con le vite delle persone (relazione Lorenzo Biagi), che spesso divengono meri fattori in un’equazione prova di soluzioni.
- Un uso puramente strumentale dello spazio pubblico - che nasca da un familismo amorale (dalla politica alla criminalità organizzata, come documentano la relazione di Gherardo Colombo o il lavoro del gruppo 6) o da un individualismo completamente autocentrato.
- L’incuranza della terra, su cui la civitas sorge, e dei beni ambientali, di cui si alimenta (ne hanno fatto cenno la relazione di Luigi Negro e quella di Paolo Ricca)
- La barbarie del rifiuto dell’altro (si vedano le relazioni di Brunetto Salvarani e di Bruno Segre), di colui che è diverso da un punto di vista culturale, etnico, religioso (nodo particolarmente critico per l’ecumenismo) o magari di orientamento sessuale.
- Un pluralismo, che, se viene declinato in forme non dialogiche, rischia di trasformarsi un elemento di sconnessione di quel tessuto civile di cui vive la civitas stessa (relazione di O.Meshri).
- 2. Parole come vie d’uscita
Come uscire da una simile distretta? Dove trovare risorse di senso alla sua altezza? Giustamente il gruppo 6 invita a “non cedere all'avvilimento e al senso di impotenza”, per ripartire invece ”dalla promessa di Gesù di non lasciarci soli”. Vorrei allora in primo luogo richiamare alcune parole chiave di una tradizione di giustizia che sa guardare alla Scrittura come fonte di senso, per rileggere alla sua luce le pratiche delle chiese, anche aldilà delle loro (talvolta corpose) contraddizioni. È una lettura che non va fatta in modo ingenuo, trasformando immediatamente in etica parole che sono in primis altro (lo sottolineava anche il gruppo 1), ma che non deve impedire di cogliere valenze ispiratrici significative.
Ecco, dunque, in primo luogo, un gruppo di parole che viene direttamente dalla Scrittura, per dire di un Dio che condivide l’indignazione per l’umanità violata: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze” dice Dio in Es. 3, 17; si tratta tra l’altro di un testo così direttamente legato alla successiva rivelazione del Suo nome, che egli potrà ormai essere invocato come “Dio, mia giustizia”(Sal. 4, 2). Di un Dio che condanna chi divora i poveri, quei mercanti che li ingannano per garantire il proprio lusso (“hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali” Am. 2, 6); di un Dio irato contro chi divora i suoi figli (“Perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo li spierò per la via, li assalirò come un'orsa privata dei figli”, Os. 13, 7-8); di un Dio che condanna Babilonia, la città nella quale i mercanti si arricchiscono con l’ingiustizia (Ap.18, 1-24). Di un Dio che, d’altra parte, benedice chi ha fame e sete della giustizia (il “Beati” di Luca parla in primo luogo di un Regno che orienta in tal senso, di un Dio che ama la giustizia ed invita a sintonizzarsi sul suo agire in una sequela intensa). Non appare casuale in tal senso che un antico amico del SAE come Enrico Chiavacci abbia potuto esprimere uno dei due assiomi centrali della sua etica sociale come invito ad operare contro ogni stato di cose oppressivo[8].
Un secondo grappolo di parole è anch’esso biblico e rimanda alla destinazione dell’umanità alla comunione, in una fraternità che corrisponda all’immagine del Dio trino. È una prospettiva ben espressa nell’icona della Nuova Gerusalemme (Ap. 21, 2), la città con porte aperte su ogni lato (Ap. 21, 12-13): una figura di convivenza articolata, in cui si esprime la costitutiva socialità degli essere umani (da realizzarsi ad immagine del Dio Trino, secondo Gaudium et Spes 24). Si tratta, tra l’altro, di un tema particolarmente caro a don Luigi Sartori, che per tanti anni è stato maestro del SAE: ancora nel 1994 egli notava come “nell’orizzonte del Regno acquista grande rilievo anche la comunione con e di tutti gli uomini e poi quella con e di tutte le realtà del creato”[9]. È il riferimento ad una civitas che sappia accogliere tutte le differenze, per costruire assieme vita buona su una terra abitabile; ad una civitas che sia spazio di pace, ad evocare quel grande simbolo esplorato da Salvarani sulle orme di Panikkar; ad una civitas – lo notava P.Ricca - capace di portare in sé la ricchezza del giardino di Gen. 2, ma modulandolo culturalmente.
Una terza parola orientatrice, nelle forme in cui l’ho appresa dalla tradizione cattolica, ma comune alle nostre chiese, si colloca all’incrocio tra le prime due ed è il riferimento alla destinazione universale dei beni della terra. Gaudium et Spes 69 affermava con forza che “Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, cosicché i beni creati debbono equamente affluire a tutti, sotto la guida della giustizia, accompagnata dalla carità”. È un riferimento significativo all’opera del Creatore, che mette a disposizione il dono perché sia condiviso; a partire da esso emerge una vera e propria categoria dell’etica teologica, che nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, ad esempio, diverrà asse portante dell’intera etica economica[10]. Ecco, così, il richiamo alla costruzione di un’economia che non sia realtà autonoma, orientata ad un arricchimento fine a se stesso, ma alla vita delle persone; che sia capace di mantenere un’attenzione alla terra e alle generazioni future.
- 3. Per pratiche rinnovate
Parole forti, incisive, che vorremmo vedere proclamate in forme chiare dalle nostre comunità, ma che ci aprono anche il problema di come collegarle con il nostro tempo e la nostra esperienza, in uno spazio drammaticamente segnato dalla complessità. Vorrei proporre allora qualche idea elaborata dalle nostre tradizioni ecclesiali, che ci può aiutare ad interpretare il nostro tempo.
Vorrei in primo luogo attingere alla tradizione ecumenica, facendo memoria della seconda Conferenza di Life and Work (l’organismo ecumenico dedicato all’etica sociale che nel 1948 confluirà nel Consiglio Ecumenico delle Chiese), tenutasi 75 anni fa Oxford nel 1937; essa ci ricorda della necessità di un’ecumene che sappia essere tale di fronte ai totalitarismi, facendo resistenza di fronte alle intolleranze. Più recenti (15 e 5 anni fa), vanno ricordate la II e la III Assemblea Ecumenica Europea (Graz 1997 e Sibiu 2007), a richiamare l’istanza di un’Europa capace di riconciliazione, nella giustizia. È quanto ricordava il già citato testo di L.Sartori, richiamando la figura di un’ecumene attenta alla stretta relazione tra unità della chiesa e rinnovamento della comunità umana[11] (un tema esplorato peraltro anche da Fede e Costituzione – l’organismo teologico del CEC nel documento su Chiesa e mondo del 1990[12]).
Vorrei però anche richiamare l’intreccio di due parole (esplorate con attenzione dal gruppo 2), di grande significato per l’elaborazione di una riflessione etico-sociale, Mi riferisco, da un lato, alla nozione di bene comune (caro alla tradizione cattolica, ma non solo): esso non può essere identificato con un preteso interesse generale, elaborato a monte della considerazione delle persone, ma neppure con la mera sommatoria di quelli particolari; si tratta piuttosto dell’insieme delle condizioni che consentono il fiorire di buone vite e di buone vite assieme, colte nella loro interdipendenza. Una sfida fondamentale per un paese come l’Italia è quella di tornare ad apprezzarne il senso, costruendo un pensiero della politica che sappia coinvolgere tutti i soggetti nella sua determinazione e nella sua costruzione. Accanto ad esso, vorrei collocare la nozione di responsabilità (centrale per l’etica protestante, ma spesso citata anche in un testo come Caritas in Veritate): essa ricorda come l’appello a cercare la giustizia sia rivolto in primo luogo ad ognuno - prima ancora che alla forma sociale in cui ci troviamo inseriti. Si pensi ad una questione come quella dell’alimentazione, che rimanda a questioni di giustizia sociale su scala globale, ma anche agli stili di vita personali (gruppo 5). È l’esigenza di un rigore e di un’affidabilità, di cui spesso avertiamo la mancanza, ma soprattutto di una disponibilità personale a spendersi per ciò che è comune.
È interessante notare che tali due nozioni convergevano nella nozione di società responsabile elaborata dal CEC già nella sua prima assemblea costitutiva (Amsterdam 1948). Se l’’intervento di L.Negro ne ha sottolineato soprattutto i limiti, mi pare però che essa raccordi istanze significative, nel rimando ad una figura di società che sia responsabile per ognuno dei suoi membri (contro l’individualismo neoliberista, contro l’assolutizzazione dell’economia), ma che contemporaneamente sia essa stessa fatta di responsabili - non sudditi, ma cittadini attivi, partecipi, mutuamente solidali. Attorno ad essa è possibile pensare efficacemente una nozione come quella di co-responsabilità, che invita a far rete, per un’azione sociale condivisa.
- 4. Problemi aperti e spazi di dialogo
Certo, tali indicazioni di fondo non esimono da una riflessione ulteriore, capace di misurarsi con i numerosi problemi che ancora restano aperti. A partire dalla riflessione sulle istituzioni, per capire quali forme debbano esse assumere per esprimere adeguatamente la responsabilità in forme democratiche; per far sì che le forme della rappresentanza esprimano davvero l’istanza di una società responsabile e non vadano invece a costituire una casta.
Più a monte, si pone la grande questione del rapporto tra il pluralismo degli orientamenti socio-culturali e quel riferimento a diritti e regole che si rivela così essenziale per tenere assieme la civitas, in modo che sia spazio per la vita di tutti e di ognuno. Si tratta di costruire patti di co-responsabilità per la giustizia – secondo la linea disegnata dal volume recentemente indicata dal esto curato da P.Naso[13]. Si tratta, però, anche di farlo senza cedere alla tentazione di considerare le diverse componenti del corpo sociale semplicemente come “stranieri morali” – secondo un’espressione fatta propri dallo stesso Naso - che potrebbero al più condividere alcune regole, ma di vedervi piuttosto persone e comunità, radicate in un dialogo che ricerca tenacemente sempre e di nuovo spazi di consenso. A.Bondolfi ci ha ricordato, del resto, una serie di riferimenti irrinunciabili per la nostra civitas - costituzionali, alla dichiarazione universale dei diritti, alla carta UE: come far spazio alla pluralità di voci che abitano il nostro spazio pubblico, senza estenuare tali elementi di consenso, ma anzi facendo in modo che il dialogo ruoti attorno ad essi, rafforzandoli? E come valorizzare la dimensione giuridica, quale componente irrinunciabile dello spazio pubblico, collocandola però anche in una stretta correlazione con una dimensione educativa, memore che le regole ci sono per rendere più agevole e migliore la vita (intervento G.Colombo)?
Bisognosa di approfondimento appare anche l’attenzione per i beni ambientali: sarà una deformazione professionale - dopo qualche libro sul tema - ma ho l’impressione che sull’interrogativo sul rapporto tra etica civile ed etica ambientale, su come articolare la civitas ed il giardino dovremmo ritornare.
Tutta da approfondire anche l’attenzione per il ruolo che le comunità cristiane possono avere in questo dibatto, su quali spazi vi siano perché esse possano per collaborare ad un discernimento condiviso - senza avocare a se stesse lo spazio pubblico, ma senza dimenticarsi di esso. Siamo in grado di valorizzare efficacemente le nostre tradizioni di riflessione sociale per comprendere saggiamente il nostro presente ed orientarci in esso – per orientare il nostro agire ed il nostro stesso essere? E come declinarle nello spazio pubblico in forme incisive, ma non arroganti? Siamo soprattutto in grado di testimoniare di una figura di chiesa credibile nell’annunciare parole di speranza per la nostra società, nel segno di quella sequela mistico-politica cui ha richiamato l’intervento di Lorenzo Biagi?
Numerosi, insomma, gli spazi nei quali occorre cercare ancora, magari per riscoprire in essi impreviste consonanze confessionali (come quella delicata segnalataci da George Vasilescu tra lo stile di carità di S.Martino e quello di abba Serapione). Proprio il valore dell’amore e della fraternità, aldilà della giustizia - non contro di essa, ma come stimoli al suo realizzarsi – è del resto una sottolineatura che accomuna la riflessione di un filosofo come P.Ricoeur[14] e la prospettiva diegnata da Benedetto XVI in Caritas in Veritate. È l’asimmetria generosa del dono che si pone come matrice generativa di rapporto sociali giusti (Biagi), secondo una linea che ha come paradigma primario quello stesso di Dio. Il tema della testimonianza, certo uno degli assi di lavoro della prossima sessione SAE, ci offre una categoria in grado di collegare il riferimento al Dio che ognuno di noi confessa e le pratiche che assieme possiamo porre in essere.
- 5. A servizio di tale ricerca condivisa: il futuro del SAE
Grazie a Maio Gnocchi, per i due mandati di servizio prezioso e generoso; è stato il III presidente – dopo Maria Vingiani ed Elena Covini e ci ha guidati con esperienza in anni non facili. Grazie alla nuova presidente, Marianita Montresor che porta freschezza, novità, creatività per tempi nuovi. Esprimo il mio apprezzamento per la nuova sede della Sessione, con elementi problematici, ma soprattutto – parecchi lo hanno sottolineato - con molte positività (recupero legame ad un territorio; facilità di incontro e di rapporto, ricchezza di spazi). È un luogo che ci consente di rafforzare quel viaggiare assieme richiamatoci da Bruno Segre: “Se vuoi andare in fretta viaggia da solo, se vuoi andare lontano viaggia in compagnia”. Ci consente di praticare efficacemente uno stile di educazione (formazione) che è antidoto forte alla demagogia (Bendaud)
Certo, occorre nuovo slancio, per ripensare con saggezza in modo da valorizzare e rafforzare ciò che è nuovo e che ci arricchisce (serata cine e teatro, meditazioni condivise… il dibattito sul rinnovamento) affinché valga a mantenere e rafforzare ulteriormente quello che costituisce il dono specifico del SAE: la realtà di una comunità ecumenica che sta assieme nonostante le difficoltà, le critiche. Si tratta di un’esperienza unica, per la quale è però essenziale l’apporto di energie nuove, di disponibilità concrete. Il primo compito della nuova presidente è l’individuazione del nuovo CE, di soggetti che si prendano in carico un testimone, che assumano con creatività e responsabilità il carico di un percorso e di un cammino. Che aiutino ad orientare un’associazione che ha anche bisogno di crescere, per una testimonianza viva nelle città e nella nostra civitas nazionale, per coltivare il “giardino dell’ecumene” (Montresor), per un servizio ecumenico – umile, ma credo, insostituibile - alla giustizia, al dialogo, alla pace.
[2] S.Rodotà, Elogio del moralismo, Laterza, Roma-Bari 2011.
[3] A.Margalit, La società decente, Guerini e Associati, Milano 1998.
[4] A.Sen, Etica ed economia, Laterza, Roma-Bari 2002; Id., La diseguaglianza. Un riesame critico, Mulino, Bologna 20103; Id., L’idea di giustizia, Milano, Mondadori 2010.
[5] Si veda il recente M.Nussbaum, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL, Mulino, Bologna 2012, ma anche Id., Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, Mulino 2001; Id., le nuove frontiere della giustizia, Mulino, Bologna 2007.
[6] Mi permetto di rimandare a S.Morandini, Da credenti nella globalizzazione. Teologia ed etica in orizzonte ecumenico, EDB, Bologna 2008.
[7] S.Hessel, E.Morin, Il cammino della speranza, Chiarelettere, Milano 2012.
[8] In tal senso E.Chiavacci, Teologia morale. Vol. 3/1 Teologia morale e vita economica, Cittadella, Assisi 1985; Id., Teologia morale. Vol. 3/1 morale della vita economica, politica, di comunicazione, Cittadella, Assisi 1990.
[9] L.Sartori, La chiesa come comunione. Appunti su due recenti testi ecumenici, in Id., Il gusto della verità. Scritti lasciati in eredità all’Istituto di Studi Ecumenici S.Bernardino, ISE S.Bernardino, Venezia 2008, pp. 315-321 (originariamente pubblicato in Studi Ecumenici 12 (1994), pp. 229-234), qui p. 318.
[10] Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice vaticana, Città del Vaticano 1994.
[11] L.Sartori, La chiesa come comunione, p. 318.
[12] Faith and Order, Church and World. The unity of the church and the Renewal of the Human Community, WCC, Ginevra 1990.
[13] P.Naso (a cura), Un patto per il futuro. Teologia, società e politica, Claudiana, Torino 2012.
[14] P.Ricoeur, Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia .

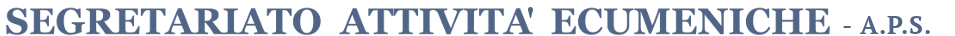
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE