Gruppo profezia e martirio – SAE - Paderno del Grappa - 2013
Gregoris Sereian - Letizia Tomassone - Vladimir Zelinskij
Nel lavoro di gruppo molto abbiamo imparato sulle storie dell’Oriente cristiano conosciute solo in modo superficiale (sulla Chiesa Armena, grazie a p. Grigori Serenian, sulla Chiesa ortodossa russa, grazie a p. Vladimir Zelinsky). Abbiamo sperimentato così quel percorso che rende l’ecumenismo una via privilegiata di comunicazione: conoscersi e ascoltare le narrazioni degli altri rende più chiare le difficoltà e le differenze, ma apre anche campi di convergenza possibile e apre la via del dialogo. Riteniamo che il termine “martirio” oggi in occidente sia ambiguo e strumentalizzabile; preferiamo usare il termine “testimonianza”. Nel gruppo abbiamo imparato il grande valore del martirio/testimonianza come condizione che indica a tutti noi cristiani la forza di Dio, quella che lui ci può dare anche in pericolo di morte; essa indica la speranza che non muore, la coscienza che la vita è di Dio. Da questa speranza nasce anche la capacità di guarire e di predicare: guarire la paura, le ansie, creando comunità in cui siano possibili la libertà, l’amore e la riconciliazione. Perciò, facendo memoria di tutte le vittime, non possiamo tenere sullo stesso piano il martirio che serve per dominare o cancellare l’altro e l’integrità che porta a conseguenze estreme. Vogliamo distinguere il martirio subìto senza possibilità di scelta, dalla testimonianza di chi non fa conto della propria vita per dire la verità e per fedeltà all’Evangelo. Non è quindi per noi un concetto strettamente confessionale ma applicabile a chiunque vive con fede e coerenza la Parola di Dio, come lo riteneva la chiesa primitiva (come tanti altri e altre, nel corso della storia, di cui citiamo qui solo Martin Luther King). Condanniamo ogni uso della violenza che produce martiri innocenti, e onoriamo la memoria di quanti e quante hanno avuto fiducia in Dio e hanno perseverato nella fede anche di fronte a poteri violenti. Riteniamo infatti che il martirio/testimonianza sia anche la fedeltà quotidiana e umile alla Parola. La violenza che nel corso della storia si è espressa contro la chiesa di Gesù Cristo o all’interno stesso della chiesa nei confronti di espressioni di fede divergenti agisce come potenza che rende mute le vittime. Spesso ai poteri violenti non basta eliminare fisicamente l’”altro”, essi vogliono cancellarne anche la memoria e rendere inaudito persino l’atto di violenza per non doverne render conto e cancellarne la vergogna (negazionismo e revisionismo si tengono nella narrazione storica). A questo proposito ecco che il valore della profezia sta nel ridare spazio alle voci ammutolite, nell’ascoltare le memorie sepolte nel silenzio. Ci impegniamo perché le differenti voci siano ascoltate, perché la parola di vita possa risuonare nella fedeltà alla parola di giustizia e di pace dell’evangelo. Al tempo stesso, poiché le memorie narrano storie diverse, la memoria delle vittime e la memoria dei carnefici possono trovare uno spazio di condivisione solo nel percorso della riconciliazione. Il perdono diventa allora uno dei nomi della profezia. Come nella commissione per la giustizia e la verità in Sud Africa, la condivisione delle memorie su cui costruire una società riconciliata passa per l’ascolto reciproco e il radicamento nella giustizia. La Parola di Dio, la parola profetica, nella storia è agente di riconciliazione. Il perdono è profezia di relazioni rinnovate, risultato di un lungo cammino, e non può essere dato per scontato senza il lavoro doloroso del porsi l’uno di fronte all’altro. Nel rifiuto dei poteri violenti siamo giunti a riaffermare l’identificazione di potere e servizio, come Cristo nell’esercizio della sua signoria si china sulle povertà dell’umanità, nel mirabile gesto della lavanda dei piedi (Giov.13,2-11). Esprimiamo la nostra speranza che ci sia una trasformazione nel senso della collegialità e del servizio e vorremo sostenere i segni del cambiamento in atto nella Chiesa cattolica romana. Come movimento ecumenico vorremmo spingere verso una maggiore collegialità all’interno della chiesa e tra le chiese. Anche qui le narrazioni intrecciate delle nostre realtà di chiese ci hanno dato conto dell’insistenza riformata sulla forma sinodale, dell’equilibrio ortodosso tra episcopè e assemblea, e della conciliarità come orizzonte nel quale iscriviamo la nostra speranza di una trasformazione delle chiese. Infine esprimiamo la nostra speranza che si creino sempre meno martiri e sempre più testimoni che vivono la fedeltà alla Parola nella quotidianità, creando quietamente spazi per la presenza dell’evangelo nella vita delle società in cui operiamo.

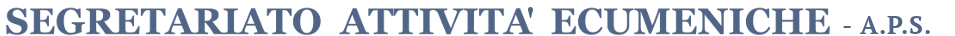
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE