


Al tema “Di generazione in generazione” hanno dato voce lo storico e saggista Bruno Segre, l’editore Daniel Vogelmann e l’organizzatrice di eventi culturali Micol Anticoli, moderati da Piero Stefani.
“Il mio retroterra familiare era composto di ebrei non religiosi, cosmopoliti e antifascisti” ha detto Bruno Segre, in un intenso excursus cha ha abbracciato tutta la sua vita. “Nacqui nell’Italia fascista e non ricevetti alcuna educazione religiosa. Mi confrontai per la prima volta con la mia ebraicità all’età di otto anni, quando le leggi razziali mi costrinsero a lasciare la scuola e mi sottrassero alla frequentazione dei coetanei”. La scomparsa prematura del padre nel 1941, e la ricerca di un rifugio nell’Italia centro-meridionale per evitare la deportazione dopo l’8 settembre 1943, furono gli eventi di maggior peso che segnarono il suo vissuto durante la II guerra mondiale.
Superato quel tragico periodo, riprese nel corso degli anni a porsi domande sul significato del suo essere ebreo. “E così mi trovai a fare i conti con il classico problema dell’identità: un tema che, qualificandomi come ebreo non religioso, ho vissuto e vivo in chiave libertaria, cioè nei termini di una ricerca mai esaurita di libertà e di autonomia d’azione e di pensiero, che ritenevo di poter condividere con molti altri membri di una minoranza storicamente ‘scomoda’, dispersa e a lungo demonizzata ed oppressa. Di qui il mio innamoramento per il progetto sionista, che nella sua formulazione originaria era radicalmente secolare; di qui, anche, l’appassionato studio di momenti e aspetti significativi della storia e della cultura ebraica”. E “andai così scoprendo per gradi l’enorme ricchezza e la dimensione straordinariamente plurale della cultura degli ebrei, avviando un percorso che con l’andar del tempo mi ha portato ad individuare, in ambito ebraico, una dimensione di ‘laicità’ declinata in positivo, costruttivo, e a mettere quindi a fuoco una visione pluralista, aperta, inclusiva della nostra cultura”.
In questo percorso – ha sottolineato – “mi è stata di grande aiuto l’interlocuzione con amici cristiani interessati come me alla pratica del dialogo. Ciò, in particolare, nei decenni successivi al Concilio Vaticano II e grazie agli esiti profondamente innovativi di tale Concilio”. Su un altro versante, “avendo a lungo presieduto l’Associazione degli Amici italiani di Nevé Shalom/Wahat al-Salam, ho avuto modo di osservare dall’interno e di cogliere con sempre maggiore precisione gli aspetti salienti del tragico irrisolto conflitto tra israeliani e palestinesi, confermandomi nella mia antica adesione allo spirito libertario del progetto sionista, alimentando in me quel senso di profonda amarezza che provo al cospetto delle violente derive nazional-clericali cui le due contrapposte debolissime dirigenze politiche stanno ora affidando le sorti dei rispettivi popoli”.
“Cominciamo dall’inizio - ha detto nel suo intervento Vogelmann -. Senza generalizzare. Sono nato ebreo nel 1948. Ovviamente, non per mia scelta. C’è chi dice che nascere ebrei sia una disgrazia (più o meno rimediabile), c’è chi dice che sia una fortuna, e c’è chi resta (saggiamente?) nel dubbio. Contando i miliardi di individui che popolano la terra è molto improbabile nascere ebrei. Nel 1948, poi, se da una parte le giovani e meno giovani coppie di ebrei, una volta passata la bufera, desideravano senz’altro procreare, non bisogna dimenticare a quanti uomini e donne la Shoah ha impedito di farlo. Per non parlare dei bambini uccisi appena nati.
Mia madre era un’ebrea italiana abbastanza assimilata. Rimasta vedova a venticinque anni alla vigilia dell’8 settembre è dovuta subito correre a nascondersi con un figlio di quattro anni prima da una famiglia di conoscenti e poi, grazie a Don Casini, in un convento. Mio padre, invece, apparteneva a una famiglia ortodossa polacca con tanto di rabbini e studiosi. E anche in Italia continuò a essere un “buon” ebreo avendo fra l’altro sposato la figlia del rabbino di Torino Dario Disegni.
Lui, la moglie e la figlia di otto anni furono arrestati dalla polizia fascista a Sondrio (cercavano di fuggire in Svizzera) e spediti ad Auschwitz. Mio padre tornò solo a Firenze. Poi si sposò con la donna che sarebbe diventata mia madre e nel 1948 sono nato io. E così il cerchio apparentemente si chiude. Il resto verte su come mi è stato trasmesso l’ebraismo e soprattutto quale ebraismo”.
“Quando sono stata chiamata a parlare di identità ebraica ho subito pensato a quanto sia difficile definire l’essere ebrei” - ha esordito Micol Anticoli - “10 ebrei avranno dieci diverse visioni dell’ebraismo, tutte ugualmente valide. Avere una identità religiosa e culturale è molto importante soprattutto per la mia generazione, la più giovane, a causa del forte individualismo delle società moderne. Avere la consapevolezza di condividere dei valori e delle tradizioni con una intera comunità è qualcosa che fa sentire le persone meno sole laddove le differenze sono ancora considerate un limite e non una risorsa.
Pensando a quando si inizi ad apprendere cosa significhi essere ebreo, mi viene in mente che non ricordo il momento esatto, direi da subito. Alla mamma infatti l’ebraismo affida l’educazione dei figli e l’insegnamento di tutti gli usi e le regole quotidiane. Al papà invece la Torah comanda esplicitamente di insegnare i principi dell’ebraismo ed a lui è affidato l’insegnamento dei testi”.
Lo studio nell’ebraismo non può essere qualcosa di statico, non una lezione frontale da impartire, ma un dialogo in cui il figlio o l’allievo possa porre le sue domande e fornire interpretazioni proprie, in modo che possa elaborare personalmente l’essenza dell’ebraismo. Lo studio teorico non può però prescindere dall’applicazione pratica delle norme, dall’azione. “Le pratiche sono infatti l’aspetto che più resta impresso attraverso le generazioni. Penso per esempio alle comunità ebraiche del sud Italia, ora scomparse, ma delle quali sono rimaste alcuni usi come l’accensione delle candele del Sabato e l’impasto del pane a forma di treccia che al giorno d’oggi ci si ritrova a fare senza neanche saperne il perché: di tutto l’ebraismo ciò che è rimasto non è lo studio, non sono le nozioni, ma degli atti pratici.
Riguardo alla trasmissione dell’identità ebraica alla mia generazione, il gap culturale può rappresentare un limite; per questo ritengo che per catturare l’attenzione dei giovani è necessario integrare i vecchi metodi di insegnamento con le nuove forme di comunicazione. Ritengo altresì che non basti più il ricordo e la memoria (nonostante questa sia un pilastro dell’ebraismo) ma occorre coinvolgere i giovani in un ebraismo vivo e dinamico, in cui la famiglia e la comunità condividano momenti positivi con le nuove generazioni. La conoscenza della propria identità, in questa ottica, non è importante soltanto per la sopravvivenza dell’ebraismo stesso, ma in funzione di un confronto consapevole con le altre religioni e le altre culture. Ho visto compagni di scuola ebrei nascondere la propria identità ebraica e soltanto dopo qualche anno ho capito perché: avevano paura di non essere compresi, avevano paura di essere derisi o considerati diversi, ma soprattutto – ha concluso - non conoscevano sé stessi”.
In una seconda tavola rotonda: “Di generazione in generazione: esperienze cristiane", sempre moderata da Piero Stefan, sono intervenuti portando la propria testimonianzaq: Claudio Paravati, direttore di Confronti, Dragoslav Trifunovic, ortodosso serbo, segretario Consiglio delle Chiese cristiane di Milano e Daniele Fortuna, teologo cattolico,
"E’ la mia storia, è la mia fè " recita l'inno protestante, scritto negli Stati Uniti nell'Ottocento. Perché la fede è, per l'appunto, la "mia storia", come si canta nella strofa, e, al contempo, la storia più ampia nella quale si è iscritti, composta da un passato testimoniato e raccontato, e da un futuro da elaborare”, ha esordito Claudio Paravati.
Se la fede non è una conquista del proprio "io", bensì la ricezione di ciò che Dio dona gratuitamente, la famiglia e la comunità sono i luoghi dove di certo la si sente raccontare. Nelle molteplici forme in cui la parola può essere detta: dalle prediche la domenica alle lezioni della scuola domenicale; dai canti alle preghiere prima di mangiare. Ma anche, oltre alle parole, nel modo in cui la fede "imposta" il proprio stare nel mondo.
Rispondere e "corrispondere" all'incontro con la fede è una quotidiana educazione a stare al mondo e, da questo punto di vista, un continuo imparare a stare "composti". E quindi stare nel mondo, vivere e testimoniare nel mondo ("Il mondo è la mia parrocchia", per John Wesley padre del metodismo). La cerniera tra le generazioni deve ricominciare dunque dal curare, con fatica, il cammino congiunto di testimoniare la fede, quotidianamente, nel mondo. “E’ un cammino che necessita di pazienza, cura reciproca, condivisione di responsabilità e compiti. Ma anche disposizione ad aprirsi alla novità, ed affrontare la fatica del "passaggio di consegne" (contenuti e soprattutto "modi" - il "come si fa"). Da questo punto di vista l'ecumenismo può essere la via privilegiata per comprendere una fede viva, che intuisce la costruzione di un mondo unito nella diversità”.
“I miei primi approcci alla fede ed alla religione – ha confidato Dragoslav Trifunovic - avvengono esclusivamente in ambito familiare. Vengo da una interconfessionale, religiosa ma non praticante. Tuttavia l’educazione ricevuta è stata di fatto, anche se forse inconsapevolmente, molto ecumenica. Da mia madre ho imparato ad esempio il Padre Nostro piuttosto che a dire le preghiere prima di dormire. Con mio padre la cosa è stata un po’ diversa; essendo lui cresciuto negli anni del comunismo, non aveva una educazione religiosa, credo con certezza che non conoscesse nemmeno il Padre Nostro; tuttavia da lui ho avuto i primi approcci sul concetto del sacro, concetto molto caro ed importante nel mondo ortodosso. In tutte queste cose c’era da parte di ciascuno dei miei genitori un tacito consenso su ciò che mi veniva insegnato dall'altro, in quanto considerato non in contrasto con le proprie convinzioni religiose. Sin da bambino avevo una certa percezione che tra i miei c’erano delle differenze religiose, ma mi era stato spiegato in maniera molto soft. Il primo approccio esterno è stato con la scuola elementare, approccio non completamente positivo dal punto di vista confessionale. La perdita di mia mamma e una conseguente situazione familiare difficile, ha fatto sì che negli anni dell’adolescenza non avessi una pressoché minima coscienza religiosa, ma vivessi invece una profonda crisi identitaria. Il giro di boa credo sia stato essermi diplomato e aver trovato praticamente quasi subito un lavoro, perché quel fatto ha in un certo senso cambiato la mia vita. L'avvicinamento alla chiesa ortodossa è stato pressoché automatico, sia a causa di alcuni ricordi e avvenimenti d'infanzia sia anche per il tipo di educazione ricevuta in casa. Il seguito – ha concluso Trifunovic - è stato un sempre più profondo interessamento all’ortodossia, culminato poi anche con un impegno nell'ecumenismo”.
“La trasmissione della fede è considerata una delle questioni spinose all’interno della chiesa cattolica già da alcuni decenni, ma, in realtà, essa avviene in modo molto più semplice di quanto si pensi, da credente a credente, come l’accensione delle candeline durante la veglia pasquale”, ha sottolineato Daniele Fortuna. “Come in una corsa a staffetta, anche la fede viene trasmessa di generazione in generazione. Al punto di partenza c’è la fede d’Israele, che ha nello Shema‘ il suo cuore pulsante. Quindi, attraverso le modalità ebraiche di trasmissione, si giunge a Giuseppe e Maria che, in quanto genitori di Gesù, plasmano la sua fede giudaica. Gesù, a sua volta, la trasmette ai suoi discepoli, con la novità della sua esperienza filiale, assolutamente unica, che identifica quel Dio d’Israele ricco di misericordia con il suo Abbà. La morte in croce di Gesù e gli eventi gloriosi che ne seguirono, apportano una luce nuova e una più completa intelligenza della fede (DV 19). I discepoli possono così trasmettere la fede di Gesù ed in Gesù, annunziando il vangelo anche alle genti ed inculturandolo presso “ogni nazione che è sotto il cielo”. Così, di generazione in generazione, la Chiesa di Gesù perpetua e trasmette “tutto ciò che essa è e tutto ciò che essa crede” (LG 8): in ultima analisi, essa trasmette la sua esperienza di comunione trinitaria e annunzia il volto misericordioso di Dio, rivelatosi pienamente nell’umanità di Gesù. Quello della Chiesa, però, deve essere un annunzio che rispetti le varie culture e le diverse modalità di accoglienza della Parola evangelica. Essa, come il seme della parabola, mantiene sempre la libertà di fruttificare a modo suo e non può essere contenuta nei nostri schemi. Inoltre, non si può trasmettere se non quanto si è già contemplato e vissuto e se non si è già trovato quel “settantunesimo senso” che attualizza la Parola di Dio al nostro oggi, dando senso alla nostra vita e rendendola profetica anche per la nostra generazione. Papa Francesco, grazie alla sua grande esperienza umana ed al suo ascolto della Parola di Dio vissuto ogni giorno nella pratica della Lectio divina, riesce spontaneamente ad entrare in empatia con la gente. Anche i giovani lo riconoscono come maestro, considerando in particolare la sua coerenza tra fede e vita. Per questo - ha concluso Fortuna - risulta un modello di trasmissione della fede. Ma alla fine tutto dipende dall’azione dello Spirito Santo: come diceva il metropolita Ignazio di Latakia, senza di Lui il Vangelo è lettera morta e la missione solo una propaganda, ma, con Lui, il Vangelo è potenza di vita e la missione è Pentecoste. Insomma, come diceva il Card. Martini, “le possibilità di diffondere la fede oggi sono assai più ampie che nel passato e Dio sta preparando cose grandi per il prossimo millennio.

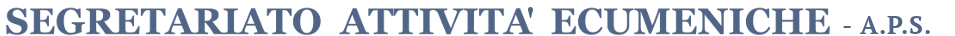
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE
