Con una chiamata al ritmo gospel – «Venite tutti, venite tutte, cantiamo al Signore» – si è aperta lunedì 24 luglio alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli la 54° sessione di formazione ecumenica del Segretariato attività ecumeniche, un’esperienza che racchiude parola, preghiera, canto, confronto, condivisione. La lettura del messaggio augurale del vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e l’intervento in sala del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, hanno rappresentato il saluto di Assisi ai 250 partecipanti provenienti da molte regioni d’Italia e dalla Svizzera.
«Il Signore dia a tutti l’abbondanza del suo Spirito e la docilità alla sua voce» ha scritto monsignor Sorrentino, assente da Assisi per impegni all’estero. «Mi rallegro per la vostra presenza qui. Il vostro impegno è nelle corde di questa città e vi ringrazio per averci coinvolti – ha detto il sindaco, che ha ricordato come Assisi sarà ancora la sede della Giornata nazionale per la custodia del Creato. «Il tema del creato è da affrontare insieme anche con chi non crede e con movimenti spirituali che non sono qui. E’ il grande tema della famiglia umana che si muove per evitare il baratro».
L’avvio della sessione è stato sotto il segno della Parola, il fondamento che accomuna cristiane e cristiani delle diverse denominazioni presenti ad Assisi. L’accensione di una lampada e una Bibbia aperta i segni che hanno accompagnato la lettura del salmo 18 e la poesia di Dietrich Bonhoeffer “Facciamo silenzio”, condizione essenziale per ascoltare la Parola. Dal fondamento è partito anche l’intervento di apertura del presidente del SAE, Piero Stefani, iniziato con una riflessione biblica sul versetto che titola la sessione: “E’ parso bene allo Spirito Santo e a noi” (At 15,28). Tra i diversi livelli in cui è leggibile e ripetibile l’affermazione della lettera derivata dall’assemblea di Gerusalemme, Stefani ha messo in luce quello di una chiesa che discute e poi si appella allo Spirito, «non come possesso ma come invocazione di una presenza. E’ questa presenza che precede e si rivela a Cornelio prima ancora che Pietro lo battezzi, perché l’iniziativa viene sempre dall’alto».
Un altro punto sottolineato dal presidente del Sae è la composizione della comunità dei credenti che ad Antiochia per la prima volta sono detti cristiani: una comunità inedita di gentili ed ebrei insieme che è posta di fronte alla difficoltà di coniugare unità e diversità. «Anche la realtà attuale ci mette di fronte a realtà inedite. Un conto è vederle, un conto è esserci dentro. Un conto è vedere l’immigrazione, un conto è vivere la condizione di immigrato. Non è una cosa facile. E l’ecumenismo sa che non è facile tenere insieme diversità e unità». Per questo l’ecumenismo, ha concluso Stefani, «è ricerca, decisione e rischio, ed ecco perché è importante che il verbo del nostro versetto sia “apparire” e non una certezza che si autopresenta come assoluta». In questa direzione vuole svolgersi la sessione attraversando diversi territori in diverse prospettive, non con la verità in tasca ma ricercando cosa significa oggi per le chiese porsi in stato di riforma per essere più fedeli al Vangelo.
Partire dal fondamento per il SAE significa anche riconoscere e ricordare le origini ebraiche del cristianesimo e il rapporto tra ebrei e cristiani dalla separazione al dialogo. Per questo la mattinata è proseguita sull’incontro delle memorie: «incontro come via attuale che consente di visitare senza confusione conflitti e memorie che sono pieni di contrasti e di avversioni», ha premesso il presidente. La prospettiva storica ha caratterizzato gli interventi di Anna Foa, docente all’Università “La Sapienza” di Roma, e del teologo Eric Noffke, docente alla facoltà valdese di teologia di Roma.
La Foa ha commentato i passi in avanti del documento vaticano “Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, pubblicato nel 2015 dalla Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, che afferma con più forza le acquisizioni del 1965 della Nostra Aetate sulla irrevocabilità della elezione del popolo ebraico e sull’abbandono della volontà di proselitismo da parte della Chiesa cattolica. La storica ha evidenziato anche la diversa ricezione del documento, entusiasta all’estero e problematica da parte delle istituzioni rabbiniche in Italia, ipotizzando come motivo la paura di assimilazione che ha segnato la minoranza ebraica nei secoli a causa della Shoà e delle dinamiche conversionistiche. Foa ritiene che oggi sia il tempo di lasciare la paura dell’età dei ghetti e del rischio di scomparire.
Eric Noffke ha fato una ricognizione nel cristianesimo del primo secolo quando l’identità cristiana era un’identità ebraica e non c’era ancora frattura tra la sinagoga e la chiesa, passando poi in rassegna due diversi modelli interpretativi del rapporto tra il cristianesimo nascente e l’ebraismo rabbinico: dal modello della sostituzione al modello della continuità che vede due religioni sorelle che hanno in comune tantissimo e sono entrambe debitrici l’una verso l’altra. Un esempio è quello del Padre nostro, che nasce come preghiera ebraica. Il vero dramma, ha osservato il saggista Bruno Segre nel corso degli interventi dalla platea, è partito più tardi del primo secolo con la svolta costantiniana perché la chiesa si è identificata con l’impero romano anche nella struttura.
Nel pomeriggio le memorie hanno toccato la Riforma protestante del XVI secolo nelle prospettive delineate da Paolo Ricca in dialogo con Gianfranco Bottoni.

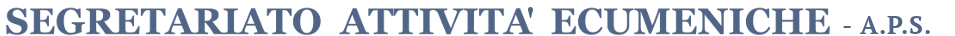
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE